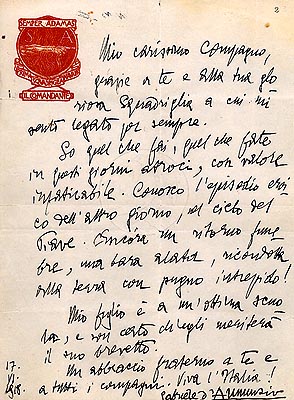LAUDI DEL CIELO DEL MARE DELLA TERRA E DEGLI EROI
la progettazione di vaste e ambiziose costruzioni letterarie, che siano commisurate al compito di diffondere il verbo del “vate”. Così, come si è visto, D’Annunzio disegna cicli di romanzi, che però spesso non porta a termine; con intenti del genere affronta la produzione drammatica; nel campo della lirica vuole affidare la summa della sua visione a sette libri di Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi: un progetto di celebrazione totale, che esaurisca tutto il reale.
Nel 1903 erano terminati e pubblicati i primi tre, Maia, Elettra, Alcyone (gli ultimi due volumi portano già la data editoriale del 1904: i titoli derivano dai nomi delle Pleiadi). Ma anche questa costruzione rimane incompiuta. Un quarto libro, Merope, viene messo insieme nel 1912, raccogliendo le Canzoni delle gesta d’oltremare, dedicate all’impresa coloniale in Libia. Postumo fu poi aggiunto un quinto libro, Asterope, che comprende le poesie ispirate alla prima guerra mondiale. Gli ultimi due libri, pur annunciati, non vennero mai scritti.
Il primo libro, Maia, non è una raccolta di liriche, ma un lungo poema unitario di oltre ottomila versi. L’opera presenta subito un’evidente novità formale: D’Annunzio non segue più gli schemi della metrica tradizionale né quelli della metrica barbara, ma adotta il verso libero: si susseguono senza ordine preciso i tipi di versi più vari, dal novenario al quinario, con rime ricorrenti senza schema fisso. Il fluire libero, irruente e concitato del verso risponde al carattere intrinseco del poema, che si presenta come carme ispirato, profetico, pervaso di slancio dionisiaco e vitalistico (il sottotitolo è infatti Laus vitae, Lode della vita). L’intento di D’Annunzio è quello del poema totale, che dia voce alla sua ambizione “panica” a raccogliere tutte le infinite e diverse forme della vita e del mondo (in greco pan significa tutto). Ne deriva un discorso poetico tenuto su tonalità costantemente enfatiche e declamatorie, gonfie e ridondanti.
Il poema è la trasfigurazione mitica di un viaggio in Grecia realmente compiuto da D’Annunzio nel 1895. L’”io” protagonista si presenta come eroe “ulisside”, proteso verso tutte le più multiformi esperienze, pronto a sprezzare ogni limite e divieto pur di raggiungere le sue mete. Il viaggio nell’Ellade è l’immersione in un passato mitico, alla ricerca di un vivere sublime, divino, all’insegna della forza e della bellezza. Dopo questa iniziazione il protagonista si reimmerge nella realtà moderna, nelle “città terribili”, le metropoli industriali orrende ma brulicanti di nuove, immense potenzialità vitali. Il mito classico vale a trasfigurare questo presente, riscattandolo dal suo squallore. Il passato modella su di sé il futuro da costruire. Per questo l’orrore della civiltà industriale si trasforma in nuova forza e bellezza, equivalente a quella dell’Ellade, ed i “mostri” del presente divengono luminose entità mitiche. Il poeta arriva così ad inneggiare ad aspetti tipici della modernità quali il capitale, la finanza internazionale, i capitani d’industria, le macchine, poiché esse racchiudono in sé possenti energie, che possono essere indirizzate a fini feroci ed imperiali.
Dopo la fuga estetizzante nella bellezza del passato, D’Annunzio aveva affidato all’intellettuale-superuomo il compito di intervenire attivamente nella realtà, aprendo la strada a una nuova èlite aristocratica, facendo rivivere la bellezza e l’eroismo del passato in un nuovo Rinascimento e cancellando così un presente infame. La contrapposizione alla realtà moderna era ancora violenta, radicale. Ora, con Maia, si ha una svolta di centottanta gradi: nel mondo moderno D’Annunzio scopre una segreta bellezza, un nuovo sublime, l’epica delle grandi imprese industriali e finanziarie. Ma, come dietro al vitalismo del superuomo si scorge pur sempre l’attrazione morbosa per il disfacimento e la morte, così dietro a questa celebrazione dell’epica eroica della modernità è facile intravedere la paura e l’orrore del letterato umanista dinanzi alla realtà industriale che tende ad emarginarlo o a farlo scomparire del tutto.
Nel secondo libro, Elettra, l’impianto mitico, le ambizioni filosofiche e profetiche lasciano il posto all’oratoria della propaganda politica diretta. La struttura ideologica del libro ricalca quella di Maia. Anche qui vi è un polo positivo, rappresentato da un passato e da un futuro di gloria e di bellezza, che si contrappongono ad un polo negativo, un presente da riscattare. Una parte cospicua del volume è costituita da una serie delle liriche sulle Città del silenzio. Sono le antiche città italiane, ora lasciate ai margini della vita moderna, che conservano il ricordo di un passato di grandezza guerriera e di bellezza artistica: quel passato su cui si dovrà modellare il futuro. Medio Evo e Rinascimento italiani sono dunque l’equivalente funzionale dell’Ellade classica in Maia. Costante è anche la celebrazione della romanità in chiave eroica, che si fonde con quella del Risorgimento (La notte di Caprera, dedicata a Garibaldi). Cantando questo passato glorioso, D’Annunzio si propone esplicitamente, non più dietro allusioni mitiche, come vate di futuri destini imperiali, coloniali e guerreschi dell’Italia.
Il terzo libro delle Laudi, Alcyone, è apparentemente molto lontano dagli altri due. Al discorso politico, celebrativo, polemico e profetico, si sostituisce il tema lirico della fusione panica con la natura; al motivo dell’azione energica, un atteggiamento di evasione e contemplazione. Il libro è come il diario ideale di una vacanza estiva, dai colli fiesolani alle coste tirreniche tra la Marina di Pisa e la Versilia: le liriche si ordinano quindi in un disegno organico, che segue la parabola della stagione, dal commiato piovoso della primavera al lento declino di settembre. La stagione estiva è vista come la più propizia ad eccitare il godimento sensuale, a consentire la pienezza vitalistica: l’io del poeta si fonde col fluire della vita del Tutto (si ricordi il significato del greco pan, che era anche il nome di una divinità agreste, in cui si incarnava la potenza della natura), si identifica con le varie presenza naturali, animali, vegetali, minerali, trasfigurandosi e potenziandosi all’infinito in questa fusione ad attingendo ad una condizione divina. Sul piano formale, alla turgidezza enfatica di Maia e alla rimbombante retorica di Elettra succede una ricerca di sottile musicalità, che tende a dissolvere la parola in sostanza fonica e melodica, con l’impiego di un linguaggio analogico, che si fonda su un gioco continuo di immagini tra loro rispondenti.
Per questo Alcyone è la raccolta poetica che è stata più celebrata dalla critica, specie da quella di orientamento idealistico, legata al gusto della lirica novecentesca: è stata vista quale poesia “pura”, sgombra dal peso dell’ideologia superomistica e delle sue finalità pratiche, immune dalla retorica e dall’artificio, rispondente al nucleo più genuino dell’ispirazione del poeta, il rapporto sensuale con la natura. In realtà Alcyone si inserisce perfettamente nel disegno ideologico complessivo delle Laudi. L’esperienza panica cantata dal poeta, lungi dall’essere “pura” di ideologia, non è che una manifestazione del superomismo: solo al superuomo, creatura d’eccezione, è concesso di “trasumanare”, di “indiarsi” al contatto con la natura, attingendo ad una vita superiore, al di là di ogni limite umano; e il gioco straordinario delle immagini, la trasfigurazione musicale della parola sono resi possibili, nella visione dannunziana, solo da una sensibilità privilegiata, più che umana. Solo la parola magica del poeta-superuomo può cogliere ed esprimere l’armonia segreta della natura (si veda La pioggia nel pineto), raggiungere e rivelare l’essenza misteriosa delle cose. Ne manca in Alcyone la ripresa diretta di certi motivi ideologici largamente sfruttati negli altri due libri delle Laudi: l’esaltazione di una violenta vitalità “dionisiaca”, la prefigurazione di un futuro di rinata romanità imperiale, l’”ulissismo”, cioè la febbre di vivere tutte le esperienze.
Alcyone di D’Annunzio, accanto alla poesia di Giovanni Pascoli, si pone così, nei suoi risultati migliori, come capostipite della poesia italiana del Novecento, con un’analoga funzione di prefigurare soluzioni formali a venire.