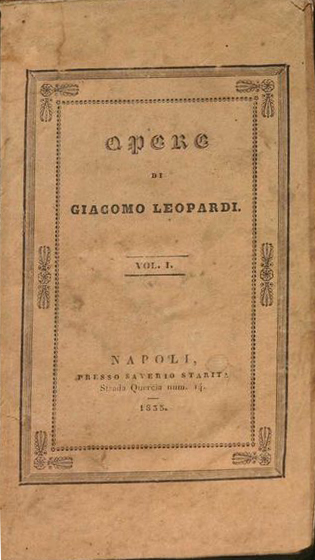Parafrasi di alcuni canti
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
O luna, cosa fai tu nel cielo? Dimmi silenziosa luna, cosa fai? Sorgi di sera e vai contemplando i deserti; infine poi scompari. Non sei ancora sazia di ripercorrere sempre gli stessi percorsi? Non ti sei ancora nauseata, sei ancora desiderosa si osservare queste valli? La vita del pastore somiglia alla tua vita. Si alza alle prime luci dell’alba , spinge il gregge attraverso i campi, e vede greggi, fonti d’acqua ed erbe; poi giunta la sera si riposa ormai stanco: altro non spera. Dimmi, o luna: che valore ha per il pastore la sua vita, la vostra vita per voi? Dimmi: dove porta questo mio vagare breve, il tuo viaggio eterno?
Un vecchietto con i capelli bianchi, malato, mezzo vestito e senza scarpe, con un grosso peso sulle sue spalle, corre via, corre, si affatica attraverso montagne e valli, su sassi pungenti, e sabbia alta, e sterpaglie, al vento e alla tempesta, e quando il tempo diventa caldo, e quando arriva il gelo, attraversa torrenti e stagni, cade, si rialza, e sempre più si affretta senza mai riposarsi o consolarsi, ferito, sanguinante; finché non arriva là dove la strada e tutta la sua fatica lo dovevano condurre: abisso orrido, immenso, precipitando nel quale egli tutto dimentica. O vergine luna, così è la vita degli uomini.
L’uomo nasce con fatica, e la nascita rappresenta un rischio di morte. Per prima cosa prova pena e tormento; e all’inizio stesso la madre e il padre si dedicano a consolarlo per essere nato. Quando inizia a crescere il padre e la madre lo sostengono, e via di seguito sempre con gesti e con parole si impegnano ad incoraggiarlo, e a consolarlo di essere uomo.: altro compito più gradito non si compie da parte dei genitori verso i figli. Ma perché far nascere, perché mantenere in vita chi poi deve essere consolato per il suo stato? Se la vita è una sventura perché da noi dura? O luna intatta, questa è la situazione umana. Ma tu non sei mortale, e forse di ciò che io sto dicendo ti importa poco.
Tuttavia tu, solitaria, eterna pellegrina, che sei così pensosa, tu forse riesci a comprendere che cosa sia questa vita terrena, le nostre sofferenze, il sospirare; che cosa sia questa morte, questo supremo impallidire del volto, e il venir meno ad ogni amata compagnia. E tu certamente comprenderai il perché delle cose, e vedrai il frutto del mattino, della sera, del silenzioso, tranquillo trascorrere del tempo.
Tu certamente sai, tu, a quale suo dolce amore sorrida la primavera, a chi faccia comodo il caldo, e che cosa ottenga l’inverno con i suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille ne scopri, che sono nascoste al semplice pastore. Spesso quando io ti osservo stare così muta stare su nella pianura deserta, che in lontananza confina con il cielo; oppure con il mio gregge ti vedo seguirmi e spostarti pian piano; e quando osservo in cielo brillare le stelle; dico dentro di me pensando perché tante scintille? Che cosa significa lo spazio infinito e quel profondo cielo infinito? Cosa vuol dire questa interminabile solitudine? E io cosa sono? Così penso tra me e me e non riesco a trovare nessuna utilità, nessuno scopo ne dello spazio infinito e superbo, ne delle famiglie numerose , poi di tanto darsi da fare, di tanti moti, di ogni astro e di ogni cosa terrena. MA tu certamente, o giovinetta immortale, conosci tutto ciò. Questo io conosco e sento, che delle eterne rotazioni, che della mia esistenza fragile, forse qualcun altro ricaverà qualche vantaggio o qualche bene; per me la mia vita è dolore.
Oh mio gregge che ti riposi, beato te, che credo non sei cosciente della tua miseria! Quanta invidia ho nei tuoi confronti! Non solo perché sei quasi priva di sofferenza; dato che ti dimentichi subito ogni stento, ogni danno ogni timore forte; ma più di tutto perché nn proverai mai noia. Quando tu stai all’ombra, sopra l’erba, tu sei calma e contenta; e in quello stato trascorri gran parte dell’anno senza provare noia. E anche io siedo sopra l’erba, all’ombra, e un fastidio mi occupa la mente, e un bisogno quasi mi stimola così che, sedendo, sono più che mai lontano da trovar pace e riposo. Eppure non desidero nulla, e fino ad ora non ho motivo per piangere. Di che cosa o quanto tu goda non lo so certamente dire; ma sei fortunato. E io, o mio gregge, godo ancora poco, né mi lamento solamente di questo. Se tu sapessi parlare , io ti chiederei: dimmi: perché giacendo comodamente senza fare nulla ogni animale si appaga; ma se io giaccio e mi riposo vengo assalito dalla noia?
Forse se io avessi le ali per volare sopra le nuvole, e contare le stelle ad una d una, o come il tuono potessi viaggiare di montagna in montagna, sarei più felice, mio dolce gregge, sarei più felice, o candida luna. O forse il mio pensiero si discosta dalla verità, riflettendo sulla condizione degli altri: forse in qualunque forma avvenga, in qualunque forma o condizione, dentro una tana o una culla, il giorno della nascita è funesto a tutti.
A Silvia
Silvia, ricordi ancora quel tempo della tua vita mortale, quando la bellezza splendeva nei tuoi occhi ridenti e fuggitivi e tu, lieta e preoccupata, stavi oltrepassando la soglia della gioventù per entrare nella giovinezza? Le stanze e le vie d’intorno risuonavano al tuo canto frequente quando, intenta ai lavori femminili, sedevi molto contenta di quell’avvenire vago che immaginavi. Era il maggio profumato e tu eri solita trascorrere il giorno in questo modo. Io lasciando talvolta gli studi piacevoli e impegnativi, nei quali si spendeva la parte migliore di me e la maggior parte del tempo, ascoltavo dal balcone della casa paterna la tua voce e guardavo la mano veloce che tesseva la tela. Io guardavo il cielo sereno, le vie dorate e gli orti rigogliosi e osservavo da un lato il mare lontano e dall’altro il monte vicino. Le parole non bastano per descrivere quello che io sentivo. Ricordi quanti pensieri dolci, speranze, sentimenti, o Silvia mia? Come ci appariva bella la vita e il destino! Quando mi ricordo di tanta speranza mi opprime il cuore questo sentimento aspro e sconsolato e torno a dolermi della mia vita sventurata. O natura, o natura, perché non dai in seguito quello che prometti prima ai tuoi figli? Tu, Silvia, prima che l’inverno rendesse arida l’erba, presa e vinta da una malattia interna, morivi, o tenerella e non vedevi la tua giovinezza; non ti addolciva il cuore la lode dolce ora dei capelli neri ora degli sguardi innamorati e schivi né le tue compagne hanno potuto parlare d’amore con te nei giorni di festa. Dopo poco è morta anche la mia dolce speranza: agli anni miei il destino non mi ha mai portato alla giovinezza. Come sei passata in fretta, mia speranza giovanile! Questo è quel mondo che io immaginavo? Questi sono gli amori e gli eventi su cui ragionammo insieme? Questo è il destino degli uomini? All’apparire della verità tu, speranza, cadesti e con la mano mostravi da lontano la morte ed una tomba spoglia e desolata.
l'Infinito
Sempre caro mi è stato questo colle solitario e questa siepe che impedisce di vedere l’orizzonte. Stando fermo e guardando fisso io immagino nel pensiero spazi infiniti al di là di quella siepe e silenzi che un uomo non può percepire e quiete profonde. Per poco il cuore non si smarrisce. E quando sento stormire le foglie a causa del vento io paragono quell’infinito silenzio a questa voce e mi viene in mente l’eternità, le stagioni passate e presenti e i scarsi rumori. Tra questa immensità si smarrisce il mio pensiero ma il lasciarsi andare in questo mare mi è gradito.
La sera del dì di festa
Dolce è la notte, chiara e senza vento. Splende la luna, luminosa sopra i tetti e gli orti, e fa sì che si intravedino le montagne da lontano. O donna mia, i sentieri sono già deserti e si vede la flebile luce di qualche lampada accesa nelle case. Tu dormi, perché il sonno ti ha accolto nella tua tranquilla stanza. E non hai preoccupazioni, tu non sai quanto sto soffrendo per te. Tu dormi, io mi affaccio a contemplare questo cielo e la natura, così bella e serena nell'apparenza, ma che me ha condannato alla tristezza. Questo giorno è stato di festa e ora ti riposi dagli svaghi. Forse in sogno ricorderai coloro a cui oggi sei piaciuta e che piacquero a te; io non sarò nei tuoi pensieri e neanche ci spero. E intanto penso a quanto tempo mi resta da vivere e a tal pensiero dal dolore mi butto per terra, e grido, e fremo. Oh, che giorni orrendi ho in questa mia giovinezza. Non lontano per la via sento il canto solitario dell'artigiano che ormai a sera tardi, dopo i festeggiamenti della giornata, torna alla sua povera casa. E mi si stringe il cuore a pensare al tempo che passa e le tracce che si perdono delle cose trascorse. Ora è passato il giorno di festa e lascia il posto al giorno feriale. E il tempo stende un velo su ogni vicenda umana. Dove sono andati a finire i tempi antichi, i segni degli illustri uomini del passato e del grande impero di Roma? Ora tutto è silenzio, il mondo riposa e la loro non presta più attenzione. Durante la mia infanzia, quando si aspettava con impazienza il giorno festivo, subito dopo che era passato, io, amareggiato, senza riuscire a prender sonno, giacevo nel letto, e nella tarda notte un canto che fra i sentieri si udiva spegnersi a poco a poco, mentre si allontanava, già allora, come ora allo stesso modo, mi stringeva di angoscia il cuore.
Il sabato del villaggio
La ragazza torna dalla campagna, al tramonto, con il fascio di erba da dare agli animali; e tiene in mano un piccolo mazzo di rose selvatiche e viole, con le quali si prepara per ornarsi domani, il giorno di festa, il petto e i capelli. Davanti alla porta di casa un'anziana siede a filare con le vicine, con lo sguardo rivolto al sole che tramonta. Racconta la sua giovinezza come se raccontasse una bella favola, quando al giorno di festa si abbelliva, e ancora sana e snella, era solita ballare la sera in mezzo a quelli che furono i suoi compagni di giovinezza. L'aria si fa scura, e il cielo, che nel crepuscolo era pallido, ora ritorna azzurro cupo e le ombre si allungano, giù dai colli e dai tetti, alla luce della luna appena sorta. Il suono di una campana annuncia la festa del giorno seguente; e a sentire quel suono, il cuore si conforta. I bambini gridano nella piazza, e saltano qua e là, fanno un rumore bello: e intanto torna lo zappatore fischiando, e fra sé e sé pensa al giorno di riposo che lo aspetta. Poi quando intorno ogni luce è spenta, e tutto tace, sento il martello picchiare, sento la sega del falegname, che lavora nella bottega alla luce di un lume ad olio, e si affretta e si dà da fare per completare il lavoro prima dell'alba.
Sabato è il più gradito giorno della settimana, pieno di speranza e di gioia: domani tristezza e noia entreranno a far parte della giornata, perché ognuno ritornerà con il pensiero alle fatiche di tutti i giorni che l'indomani riprenderanno. Giovinetto allegro, questa età fiorita è come un giorno pieno di allegria, che precede la festa della tua vita. Fanciullo, goditi questo stato soave, questa stagione lieta. Non voglio dirti altro; ma non ti dispiaccia se la giovinezza e l'età matura tardano a giungere.
La quiete dopo la tempesta
La tempesta è passata: sento gli uccelli che fanno festa, e la gallina, tornata sulla via, che ripete il suo verso. Ecco il sereno appare improvvisamente da ponente (ovest), verso la montagna; si sgombra (dalla nebbia) la campagna e appare chiaro il fiume nella valle. Ogni animo si rallegra, da ogni parte riprende il rumorio (soliti rumori), riprende il consueto lavoro. L’artigiano guarda il cielo umido con la sua opera in mano e cantando (segno di gioia) si affaccia sull’uscio. In fretta esce la
fanciulla a raccogliere l’acqua piovana appena caduta; e l’ortolano ambulante ripete di sentiero in sentiero il consueto grido. Ecco che torna il sole, ecco spende sulle colline e le case. La servitù apre le finestre, le porte dei terrazzi e le logge: e dalla via maestra si sente da lontano il tintinnio di sonagli; stride il carro del viandante che riprende il suo viaggio. Ogni animo si rallegra. Quando la vita è così dolce e così gradita come ora? Quando l’uomo con tanta passione si dedica alla sua occupazione? O torna al lavoro? O intraprende una cosa (attività) nuova? Quando dei suoi mali nemmeno si ricorda? Il piacere è generato dall’affanno; gioia vana (tolto il dolore, anche il piacere sparirebbe), frutto del timore passato (cessato), a causa del quale (timore) colui che odiava la vita arrivò a temere la morte; a causa del quale in un lungo tormento, le persone agghiacciate, mute, pallide (dalla paura) sudarono freddo e palpitarono vedendo i fulmini, nubi e vento rivolti verso di loro. O natura generosa (ironicamente), questi sono i tuoi doni, le gioie che offri ai mortali (constatazione). Sfuggire al dolore è per noi motivo di gioia. Spargi abbondantemente le sofferenze; il dolore nasce spontaneamente: e quel poco piacere che talvolta, per prodigio e miracolo, scaturisce dall’affanno è davvero un gran guadagno. O genere umano caro agli dei! Puoi ritenerti molto felice se ti è concesso di tirare il fiato (breve tregua) da qualche dolore: beata le la morte ti libera da ogni dolore.
La ginestra
o il fiore del deserto
Qui sul fianco riarso del monte Vesuvio, tremendo annientatore, che nessun altro tipo di vegetazione rallegra, spargi i tuoi cespi solitari intorno, profumata ginestra, appagata dai deserti. Ti vidi anche un’altra volta adornare con i tuoi cespi le solitarie campagne che circondano le città che un tempo furono dominatrici di popoli, e sembrano rendere al viandante una testimonianza e costruire un monito dall’antica potenza ormai perduta della città con il loro cupo e silenzioso aspetto. Adesso torno a vedere in questo luogo te, che prediligi i luoghi tristi e abbandonati dalla gente, te che sei compagna di rovinate grandezze. Questi campi cosparsi di ceneri sterili e ricoperti dalla lava solidificata, che risuona sotto i passi del viandante, dove si annida e si contorce al sole il serpente, e dove all’abituale tana sotterranea torna il coniglio; furono villaggi prosperi e campi incolti, e biondeggiarono di messi, e risuonarono di muggiti di mandrie; furono giardini e ville sontuose, che offrirono gradita ospitalità al riposo dei potenti; e furono città famose che con i suoi torrenti di lava fuoriusciti dal cratere che erutta fuoco, il Vesuvio investendo con la lava seppellì con gli abitanti insieme. Oggi le rovine avvolgono il paesaggio desolato dove tu solo dimori, o fiore gentile e, quasi rivelando compassione per le altrui sciagure, emani un profumo dolcissimo che sale verso il cielo e che consola questo luogo di desolazione. Chi ha l’abitudine di esaltare con ottimismo la nostra condizione venga in queste campagne desolate e constati in che misura il genere umano stia a cuore alla natura che ci ama. E qui potrà anche giudicare opportunamente la potenza del genere umano, che la natura, crudele nutrice, quando l’uomo meno se lo aspetta, con una scossa impercettibile in parte distrugge in un momento e può con scosse un po’ più forti annientare del tutto. Su questi pendii sono rappresentate le sorti splendide e in continuo progresso dell’umanità.
Vieni a guardare e a verificare le tue certezze in questi luoghi, secolo stolto e superbo, che hai lasciato la via percorsa fino ad ora prima di te dal pensiero risorto con il Rinascimento e, volti i passi in opposta direzione, esalti il ritorno alle passate dottrine e lo chiami progresso. Tutti gli intellettuali di cui il destino ingiusto ti rese padre esaltano il tuo ragionare infantile, benché, talvolta, nel loro intimo, ti scherniscano. Io non andrò sottoterra macchiato di una simile vergogna, ma avrò rilevato nel modo più esplicito il disprezzo che nutro verso di te, benché sia consapevole che chi non piacque ai propri contemporanei è destinato ad essere dimenticato: nonostante io sappia che dimenticare preme chi alla propria età increbbe troppo. L’essere dimenticato, che con te sarà comune, fin da questo momento assai mi rido. Elabori progetti di libertà politica e civile e nel contempo assoggetti a dogmi irrazionali quel pensiero in virtù del quale soltanto risorgemmo in parte dalla barbaria medioevale e in nome del quale soltanto si avanza sulla strada della civiltà, la civiltà che sola rende migliore il destino della società. Non avevi la forza di accettare le conclusioni a cui era giunto il pensiero, ossia che la natura ci ha assegnato una condizione dolorosa e infima nella gerarchia degli esseri. Per questo volgesti le spalle a quel pensiero filosoficocce rese evidenti queste verità e, mentre fuggi, definisci vile chi segue queste dottrine e, viceversa, chiami coraggioso colui che illuminando se stesso o gli altri innalza, esaltandola, la condizione umana fino al cielo.
Un uomo di umile condizione ed infermo, che abbia grandezza d’animo e nobili sentimenti, non si vanta né si illude di essere ricco o forte e non ostenta ridicolmente una vita splendida o un fisico in piena salute fra la gente; ma senza vergognarsene non nasconde di essere debole e povero e si dichiara tale apertamente e giudica la sua condizione secondo quello che è in realtà. Non considero saggio e coraggioso, ma stolto quel essere vivente che, benché destinato a morire e cresciuto in mezzo ai dolori, dichiara di essere stato creato per provare piacere e stende scritti che trasudando orgoglio disgustoso, promettendo esaltanti destini e straordinarie felicità – quali non solo questa terra, ma anche il cielo intero ignora – a popoli che un maremoto, un’epidemia, una scossa di terremoto distruggono in un modo tale che a stento rimane il ricordo di essi. Considero indole nobile e dignitosa quella di colui che ha il coraggio di guardare in faccia il destino umano e che con franchezza, senza finzioni, riconosce la sorte dolorosa e l’insignificante e fragile condizione che ci furono assegnate; è quella che si rivela grande e forte nelle sofferenze, che non ritiene responsabili delle sue sciagure gli altri uomini, aggiungendo in questo modo alle sue miserie, tanto numerose, odio e ira tra fratelli, ossia un male ancora peggiore, ma attribuisce la colpa a colei che è la vera responsabile, che è madre degli uomini, in quanto li ha generati, ma, per il trattamento che riserva loro, è da considerarsi alla stregua di una matrigna. Considera la natura una nemica, pensando, come del resto è, che la società umana si sia unita e organizzata all’origine per combattere e contrastare la natura, ritiene che tutti gli uomini siano alleati fra loro, e tutti abbraccia con amore vero, prestando valido e sollecito aiuto e aspettando in cambio nei pericoli che a vicenda sovrastano gli uomini e nelle sofferenze della lotta che li accomuna contro la natura. Ritiene che sia da sciocchi armare la propria mano per contrastare un altro uomo e preparare insidie e danni al proprio vicino così come sarebbe sciocco in un campo circondato da nemici, proprio mentre infuriano gli assalti, dimenticandosi di questi, aprire ostilità crudeli e feroci contro i propri compagni. Così fatti pensieri quando saranno, come furono agli inizi dell’umanità, evidenti al popolo, e quel terrore che alle origini spinse agli esseri umani a stringere legami sociali contro le forze naturali ostili sarà ricondotto da una vera conoscenza, allora i rapporti civili ispirati ad onestà e rettitudine, la giustizia e la pietà, avranno un ben diverso fondamento che non le fantasie piene di presunzione e prive di consistenza, basandosi sulle quali l’onestà umana suole stare in piedi, così come può stare in piedi tutto quello che si fonda sull’errore.
Spesso in questi luoghi alle pendici del vulcano che, desolate, la lava solidificata ricopre di scuro, e sembra accavallarsi come onde marine, trascorro la notte; e sulla campagna triste in azzurro purissimo vedo dall’alto brillare le stelle, cui da lontano il mare fa da specchio, e tutto in giro di scintille nella cavità serena, immensa, del cielo brillare il mondo. E poi che gli occhi a quelle luci rivolgo, che agli occhi sembrano un punto, mentre sono immense, tanto che rispetto a loro la terra e il mare sono davvero un punto; per quelle stelle non solo l’uomo, ma anche questo pianeta dove l’uomo è nulla è sconosciuto del tutto; e quando scruto quella ancora lontana nebulosa, che a noi pare quasi nebbia, a cui non l’uomo e non la terra soli, ma insieme, infinite nel numero e nella grandezza, le stelle del nostro sistema solare, compreso il sole luminoso o sono sconosciute, o così paiono come essi alla terra, un punto di luce nebulosa; al pensiero mio che sembrino allora, o genere umano? E io, ricordando la tua condizione miserevole, di cui è testimonianza il luogo in cui mi trovo che, nonostante ciò, tu, credi di essere stata destinata ad essere dominatrice e scopo ultimo dell’universo, e quante volte ti sei compiaciuta immaginando che gli dei, creatori dell’universo, siano scesi in questo oscuro granello di sabbia che ha nome a terra per prendersi cura di te ed abbaino conversato con piacere insieme agli uomini e che perfino il secolo attuale, che pare di tanto superiore alle età precedenti per conoscenze e grado di civiltà, col restaurare le credenze religiose schernite nel Settecento, insulta coloro che conservano un po’ di saggezza, quale sentimento o quale riflessione prevale allora in conclusione nei tuoi riguardi, o infelice genere umano? Non so dire se prevale il riso per l’assurdità dei tuoi errori o la pietà per il bisogno di conforto che ti induce a quelli.
Come un frutto di modeste dimensioni, nel cadere da un albero, che il semplice processo di maturazione fa precipitare a terra in autunno inoltrato, senza l’intervento di alcuna forza e schiaccia, annienta e sommerge in un attimo gli amati nidi scavati dalle formiche con grande fatica e lavoro e provviste che i laboriosi insetti avevano accumulato con previdenza, a gara, durante l’estate; allo stesso modo le tenebre ed una valanga piombando dall’alto, dopo esser stata scagliata verso il cielo dalle viscere rombanti del vulcano, oppure un’immensa piena di massi liquefatti, o di metalli e di arena infuocata, scendendo furiosa tra la vegetazione lungo il pendio della montagna, devastò, distrusse e ricoperse in pochi istanti le città che il mare lambiva là sulla costa: per cui sopra le città sepolte oggi pascolano le capre, e nuove città sorgono dall’altra parte, distanti dal mare, di cui le città sepolte costituiscono le fondamenta, e le mura diroccate, l’altro monte al suo piede quasi calpesta. La natura non nutre verso la specie umana più sollecitudine e interesse di quanto nutre verso le formiche, e se avviene che le stragi sono meno frequenti tra gli uomini che tra le formiche, ciò dipende solo dal fatto che la stirpe degli uomini è meno feconda.
Ben milleottocento anni passarono dopo che sparirono, sepolti dalla forza della lava infuocata, le città popolose e il giovane contadino addetto ai vigneti, che la terra arida e bruciata fa crescere a stento in questi campi malgrado siano passati tanti secoli alza lo sguardo con apprensione alla sommità del vulcano, che neppure minimamente si è fatta più mite ed ancora sovrasta tremenda, ancora minaccia a lui strage ed ai figli e ai loro averi poverelli. E spesso il meschino trascorrendo la notte insonne all’aperto sul tetto della modesta abitazione e balzando più volte, scruta con attenzione l’avanzare del fronte lavico che si riversa dall’interno del vulcano sul pendio sabbioso, al cui bagliore riluce la marina di Capri, il porto di Napoli e Mergellina. E se lo vede avvicinarsi, o se mal sente gorgogliare nella profondità del pozzo di casa l’acqua che ribollendo segnala il sopraggiungere della lava, sveglia i figli, sveglia la moglie in fretta, e via, con ciò che delle loro cose possono sottrarre alla distruzione; scappando, vede da lontano la sua abitazione di sempre, e il piccolo campo, che li fu l’unica difesa dalla fame, essere lambito dal fronte lavico che avanza, e inesorato per sempre si distende sul campo e sull’abitazione per sempre si distende sul campo e sull’abitazione. Pompei, cancellate dall’eruzione, torna alla luce dopo un oblio protrattosi per molti secoli, che l’avidità di guadagni o un sentimento di pietà restituiscono alla luce togliendolo dalla terra; e il visitatore contempla dalla piazza deserta, stando tra le file dei condannati diroccati, la sommità ancora minaccia le rovine sparse intorno. E nell’errore delle notte che cela ogni cosa per i vuoti teatri , per i templi che non hanno più la forma originaria e per le case dal tetto sfondato, dove il pipistrello nasconde i piccoli per proteggerli, come una fiaccola infausta che lugubre si aggiri per i palazzi vuoti, avanza il bagliore della vita che porta lutti con sé, che da lontano rosseggia nelle tenebre della notte e colora i luoghi tutto intorno. Così la natura sta immobile, sempre giovane, indifferente all’uomo, alle età che egli chiama antiche e al susseguirsi delle generazioni, o meglio, avanza anch’essa ma con un processo così lento che sembra stare immobile. Nel frattempo i ragni, i popoli, le nazioni vanno in rovina; la natura assiste impassibile, e l’umanità rivendica a se con arroganza il vanto dell’immortalità. E tu, flessibile ginestra, che con i tuoi cespugli profumati adorni queste campagne desolate, anche tu presto soccomberai alla crudele possanza del fuoco sotterraneo, che ridiscendendo per il medesimo percorso stenderà il suo flutto infuocato, avido di distruggere e bruciare tutto quello che incontra, sui tuoi cespugli flessibili. E tu, senza opporre resistenza piegherai il tuo capo innocente sotto il peso della lava che provoca morte: ma non avrai piegato il tuo capo prima di allora per supplicare inutilmente in modo codardo davanti al fuoco della lava che sta per sopprimerti; ma non hai mai alzato il tuo capo con insensata presunzione alle stelle, né lo hai eretto sul deserto dove, non per tua volontà ma per caso, cresci e sei nata, ma tanto più saggia, tanto meno insensata dell’uomo, in quanto non hai mai avuto la presunzione di ritenere che la tua stirpe fosse stata resa immortale ad opera del destino o tua.
Ultimo canto di Saffo
Oh placida notte e trasparente raggio della tramontante luna; e tu stella di venere che annunci il giorno fra la silenziosa selva da sopra la rupe; voi foste ai miei occhi dilettose e care sembianze, fino a quando non vissi le furie dell'amore e il mio spietato destino; il dolce spettacolo della natura non rallegra gli animi infelici.Una felicità inconsueta ravviva noi (animi infelici), quando l'onda dei venti turbina nell'aria limpida, e quando il tuono, tuonando sopra di noi,
squarcia l'aria tenebrosa del cielo. A noi piace stare tra le nebbie e ci piace Andare per le colline e per le profonde valli, a noi piace vedere la disordina fuga delle greggi impauriti, a noi piace sentire il fragore e il movimento dell'onda di un fiume in piena presso la pericola sponda.
Il tuo manto è bello, o divino cielo, e tu, o terra rugiadosa, sei bella. Ahi gli Dei e la sorte crudele non fecero Partecipare in alcun modo alla povera Saffo di così tanta infinita bellezza. Io, addetta ai tuoi superni regni, come una vile e fastidiosa ospite, e come un'amante disprezzata, o natura, rivolgo invano e supplichevole il mio cuore e i miei occhi alle tue belle e graziate forme. Il soleggiato luogo e il mattutino albore Non mi sorride; né il canto dei colorati uccelli Né il mormorio dei faggi mi sorride; né un luogo mi sorride dove il chiaro rivo fa scorrere le sue limpide acque e sottrae, mostrando sdegno, le sue serpeggianti acque al mio malfermo piede e nella fuga urta le profumate rive.
Quale colpa, quale misfatto gravissimo Mi rese rea prima della mia nascita A causa dei quali il Padre del cielo e Il volto della fortuna mi furono ostili?
In che cosa peccai bambina, quando la vita è priva di misfatti, cosi ché poi privato della giovinezza e del fiore della vita, cioè dell'amore ( U. Dotti)
tanto che il filo oscuro della mia vita scorresse ( più lento o più rapido ?) nel fuso dell'implacabile Parca ? (Risponde il Leopardi per bocca della Saffo).
La tua bocca fa domande inspiegabili; una legge misteriosa muove i predestinasti eventi; tutto ciò che accade nell'universo è misterioso, tranne il nostro dolore. Noi uomini siamo una specie disprezzata e nascemmo per dolerci e la ragione del nostro dolore è posta sulle ginocchia degli Dei. Oh desideri, oh speranze, della mia più verde gioventù! Giove ha dato dominio duraturo Sulle genti alle forme, alle belle forme; e la virtù non appare nelle grandi imprese,
né nella dotta poesia né nel canto, se posta in un corpo disadorno.
(Ritorna a parlare Saffo per se stessa). Morirò. E dopo che il mio corpo indegno Rimarrà a terra, la mia anima nuda Fuggirà verso Dite, dio degli inferi,
e correggerà il tremendo e crudele errore del cieco dispensatore dei casi. E tu, Faone, a cui un lungo amore e Una lunga fedeltà e una inutile passione
Mai appagata mi tenne legata, Vivi felice se mai un uomo mortale È vissuto felice sulla terra. Giove non mi ha bagnata con il suo Prezioso liquore conservato nella piccola ampolla, cosi ché le illusioni e i miei sogni della mia fanciullezza perirono. Ogni giorno più lieto della nostra età per primo fugge. La malattia, la vecchiaia ed infine la gelida morte subentra. Ecco adesso solo il Tartaro mi resta, fra i tanti sognati onori e i lusinghevoli sogni della giovinezza ora troncati dalla realtà e, qui, dalla morte imminente; e la tenaria Proserpina e la buia notte e la silenziosa riva già posseggono il mio alto e raro ingegno.
Imitazione
Staccata dal proprio ramo, povera foglia fragile, dove vai? Il vento mi ha portato via dal faggio su cui sono cresciuta. Mi staccò il vento. Esso (il vento) cambiando di volta in volta direzione volando sul bosco, sulla campagna, mi porta dalla valle alla montagna. Con il vento vado continuamente come un pellegrino, e non so nient'altro: ignoro tutto ciò che sia diverso da questo essere portata dal vento; risponde all’interrogativo del v.3). Vado dove vanno tutte le altre cose, dove va naturalmente la foglia di rosa e la foglia d'alloro (forse si tratta di un riferimento alla fugacità della bellezza e della gloria).
A se stesso
Ora ti acquieterai per sempre Stanco mio cuore. E’ finito l’ultimo inganno (l'ultima illusione, l'amore per Aspasia), che io avevo creduto eterno. E’ finito. Sento ormai che non è cancellata solo la speranza, ma persino il desiderio dei dolci inganni d’amore in noi. Acquietati per sempre. Troppo palpitasti. Non vi è oggetto che meriti i tuoi turbamenti, né di moti di desiderio è degna la terra. La vita è solo dolore e noia e nient’altro e tutto il mondo è fango. Riposati ormai, disperati per l’ultima volta. L’unico dono accordato dal fato al genere umano è il morire. Ormai disprezzato dalla natura, potere cattivo che insidiosamente domina a comune danno sull’infinita vanità di tutto.