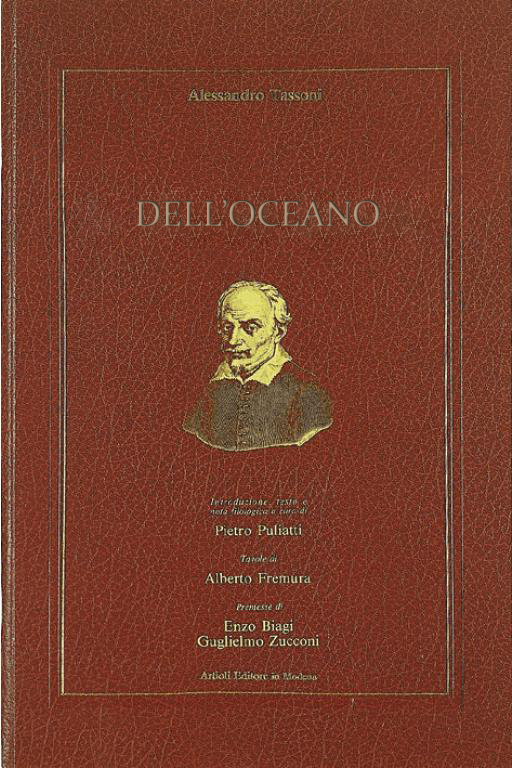Il genere dell’epica nel Seicento si collega in gran parte al Cinquecento di Tasso in cui da un lato troviamo la riscoperta della Poetica aristotelica e dall’altro, con la Gerusalemme liberata (1575), abbiamo una coerente e piena espressione dei valori culturali, morali e ideologici dell’età del Manierismo e della Controriforma uniti al rigore strutturale e finalistico propugnato nei libri della Poetica. Il Seicento presenta una ricca produzione di poemi eroici; molti scrittori si rifanno alla mitologia o a fatti legati al conflitto tra Chiesa e Medioriente (come la battaglia e la presa di Lepanto, 1603), ma si accontentano di imitare, senza produrre nulla di originale e la qualità resta modesta. Autori come Chiabrera (La Gotiade, 1582), Bracciolini (La croce riconquistata, 1605-1611) e Lalli (La Gerusalemme desolata, 1630) si cimentano nella stesura di opere eroiche ma nessuno dei poeti epici del Seicento diede vita a qualcosa di valore lasciando il modello tassiano in evidente declino. L’epica, senza aver prodotto in Italia un grande poema seicentesco, cede il posto alla poesia eroicomica, vera rivoluzione originale nel campo delle opere di ampio respiro. Il rifiuto di un classicismo cieco rende una della caratteristiche principali del secolo il rovesciamento radicale dei criteri costitutivi. Da un punto di vista dell’evoluzione letteraria venivano ormai sentiti come antiquati coloro che si sforzavano di rispettare le regole che Tasso aveva fissato nei Discorsi del poema eroico (1587) e messo in atto nella Gerusalemme liberata. Valori come l’imitazione del vero, o della superiorità dell’argomento storico rispetto a quello di fantasia, non sono più sentiti come valori fondamentali. Il poema eroicomico assumeva lo stesso metro del poema eroico, l’ottava, e ne riprendeva i temi, stravolgendoli però nel ridicolo ed eliminando dunque il principio tassiano di un poema epico di argomento “virtuoso e pietoso” in linea col “miscere utile dulci” di Orazio. Da questo contesto nasce la parodia del genere epico, di cui Tassoni fu iniziatore insieme al contemporaneo Bracciolini (Lo scherno degli dei del 1618 che però, più che un poema eroicomico, è un poema gioioso in cui si fa un’allegra parodia di miti conosciuti e poco ricercati). Fra gli altri poemi eroicomici, non mancò neppure la parodia dell’Eneide di Giovan Battista Lalli (L’Eneide travestita, del 1634).
Tassoni nelle biografie è descritto come un uomo dal carattere stravagante, amante del paradosso e ricco di contraddizioni, polemico, dall’ingegno vivace ed estroso; ne è una prova l’abbondante produzione saggistica. Per fare qualche esempio, del 1602 è la stesura delle Considerazioni sopra le «Rime» del Petrarca (pubblicate nel 1609), la prima espressione della rivolta secentesca contro la riproduzione pedissequa del modello petrarchesco e il dogmatismo degli aristotelici.
Al contrario di quanto si aspettava, la fama di Tassoni è affidata proprio alla Secchia rapita, poema in ottave di endecasillabi (ABABABCC) pubblicata a Parigi nel 1621, e ritoccata per soddisfare le richieste della Congregazione dell’Indice. L’edizione romana del 1624 infatti presenta due lezioni: una, in pochi esemplari, destinata al papa e una seconda destinata al grosso pubblico e corrispondente alle scelte originali dell’autore. L’edizione definitiva uscirà a Venezia nel 1630, ma il poema era già conosciuto al pubblico prima del 1618, anno in cui uscì l’opera di Bracciolini Lo scherno degli dei; tra i due, rispetto alla cronologia di pubblicazione, nacque una polemica riguardo la paternità del genere eroicomico, che però va senza dubbio attribuita a Tassoni se non altro per la qualità compositiva decisamente inferiore e la scarsa inventiva dell’ “avversario”.
Nella Secchia la volontà dissacratoria appare già dal titolo; il riferimento al rapimento di Elena è evidente. L’Iliade, modello autorevole della produzione epica cinquecentesca, viene qui rovesciata e messa in parallelo con una guerricciola medievale. Il trattamento solenne di una materia “irrilevante” e il trattamento umile di vicende serie sono le costanti stilistiche del poema. La contaminazione tra alto e basso implica un rovesciamento delle regole che comporta la degradazione, attraverso la parodia, del modello stesso del poema eroico e la distruzione dell’ideale di ordine e di eroismo che a questo si collega.
A partire dall’incipit del primo canto “Vorrei cantar quel memorando sdegno/ ch’infiammò già ne’ fieri petti umani /un’infelice e vil Secchia di legno /che tolsero a i Petroni i Gemignani” Tassoni esprime il suo intento di rovesciamento del modello. Se lo confrontiamo con l’incipit della Gerusalemme Liberata “Canto l’arme pietose e ‘l capitano /che ‘l gran sepolcro liberò di Cristo. /Molto egli oprò co ‘l senno e con la mano, /molto soffrì nel glorioso acquisto” possiamo notare già alla prima lettura le macro diversità. I primi due versi sono per entrambi gli scrittori dedicati all’auto presentazione come poeti: “canto” e “vorrei cantar”. Tassoni utilizza il verbo al condizionale, verbo dell’insicurezza; non si presenta affatto come un poeta sicuro di sé, portavoce di una grande tradizione o consapevole dispensatore di alti valori. Quasi ci dice che vorrebbe trattare la materia tipica dell’epica, se potesse, ma in realtà la sua è una storia che parla di una secchia di legno e di una piccola guerra medievale, che di eroico ha ben poco. Sempre nei primi versi, infatti, abbiamo l’esposizione della materia: Tasso ci presenta un capitano (Goffredo di Buglione) al comando di una pia impresa come la liberazione del sepolcro di Cristo (prima crociata, 1096-1099). Tassoni anche ci presenta un soggetto che sembra degna di trattazione epica: lo sdegno memorando che addirittura infiammò fieri cuori, ma tutta la tensione epica dei primi due versi viene fatta precipitare nella rima “sdegno-legno” già al terzo verso perché la lotta che infiammò i cuori aveva per oggetto una secchia “infelice e vil” (tutto l’opposto di quel “gran sepolcro” di cui narra Tasso). Il parallelismo formale viene così ribaltato dal rovesciamento dei contenuti e crea il conseguente svuotamento del modello, la cui presenza è facilmente riconoscibile grazie a semplici espedienti di recupero (come il verbo “cantare” nella stessa posizione iniziale,o l’esposizione della materia nei primi due versi). La differenza, oltre che nella materia trattata e nella caduta (meccanismo che diventerà costante nel testo), risiede anche nella coralità del testo tassoniano rispetto a quello tassiano; in Tassoni non c’è un vero e proprio eroe principale e la vox populi è molto più presente. Nel suo incipit non c’è spazio per un unico protagonista in cui identificarsi o che si faccia portavoce di grandi valori.
La struttura, poi, è quella che si richiede per un poema epico perfetto: ottave di endecasillabi, come codificato da Tasso, ma la narrazione è affidata al meccanismo, vitale e cardine per l’opera, del rovesciamento delle situazioni. L’imprevedibilità diventa irrinunciabile e ogni situazione si risolve con la costante disillusione delle aspettative. Il meccanismo di creazione dell’elemento divertente per lo più si basa sull’accostamento di elementi incongrui; il comico, come dice l’autore nella prefazione, deve nascere dal vivo contrasto che deriva dal «mescolare il piccante e il ridicolo con il grave e il serio ». In questo Tassoni risulta nuovo, distaccandosi da altri poeti che avevano cantato «una materia tutta burlesca con versi gravi o una materia tutta grave con versi burleschi ». Lo scopo dichiarato dal poeta fu quello del divertimento e non un’elevazione morale o religiosa del lettore; il suo strumento è la sperimentazione di una nuova costruzione letteraria, e lui stesso si dice mossa da «..curiosità di vedere come riuscivano questi due stili mischiati insieme, grave e burlesco; imaginando che, se ambidue dilettavano separati, avrebbono dilettato congiunti e misti, se la mistura fosse stata temperata con artificio tale che dalla loro scambievole varietà tanto i dotti quanto gli indotti [gli ignoranti] avessero potuto cavarne gusto» (introduzione alla Secchia). Tassoni aggiunge inoltre, con estrema varietà di materiali e di stili, episodi cavallereschi, lirici, idilliaci e parodie mitologiche (come la batracomiomachia dello Pseudo Omero, libro II lassa 43). Lo schema dell’azione proposta dal poema ripropone l’impalcatura del poema eroico, ma Tassoni opera su questa un innesto di elementi destinati a svuotare dall’interno il significato alto e assoluto del genere eroico, sintesi dei massimi valori civili e religiosi del secondo Cinquecento.
Pure l’argomento è storico, come codificato; viene però scelto secondo un criterio ben diverso da quello seguito da Tasso, che aveva rappresentato lo scontro tra la Cristianità e gli “Infedeli”. Come afferma l’autore nell’introduzione, firmandosi Accademico Umorista di Roma: «La secchia rapita, poema di nuova spezie inventata dal Tassone, contiene una impresa mezza eroica e mezza civile, fondata su l’istoria della guerra che passò tra i Bolognesi e i Modanesi al tempo dell’imperador Federico secondo […] Il poema della Secchia Rapita ha per tutto ricognizione di Istoria e di Verità. L’impresa è una e perfetta, cioè con principio, mezzo e fine». Se i singoli fatti (di portata limitata) sono dunque storicamente provati, e il fatto narrato, anche se corale, è uno soltanto (dunque rispetta il precetto aristotelico di unità), l’autore parla di un’impresa “mezza eroica” e si prende la libertà di invertirne l’ordine: il furto della secchia, che nel poema dà l’avvio alla guerra, avvenne in realtà alcuni secoli dopo i fatti che nel poema concludono il conflitto.
L’azione si svolge nel secolo XIII al tempo dell’imperatore Federico II e del suo alleato Ezzelino III da Romano, ma i riferimenti alla contemporaneità sono numerosi come pure non mancano riferimenti polemici di carattere personale che contribuiscono a vivacizzare i personaggi. Il poeta trae ispirazione da un fatto realmente accaduto nel 1325, quando i Bolognesi, fatta irruzione nel territorio di Modena, furono respinti ed inseguiti fino alla loro città dai Modenesi, che, fermatisi presso un pozzo per dissetarsi, portarono via come trofeo di guerra una secchia di legno. Tassoni immagina che, al loro rifiuto di riconsegnare la secchia, i bolognesi dichiarino guerra ai modenesi. Alla fine il conflitto si conclude con l’intervento del legato pontificio a queste condizioni: i Bolognesi si tengano prigioniero re Enzo, i Modenesi si tengano la secchia.
Alla guerra partecipano, distribuiti tra le due parti, gli dei dell’Olimpo. A favore dei modenesi combattono personaggi storici come re Enzo, figlio dell’imperatore Federico II, e personaggi immaginari, come la bella guerriera Renoppia, che comanda una schiera di donne, ed il conte di Culagna. Così come fonde insieme personaggi storici e personaggi immaginari, Tassoni rappresenta insieme, anacronisticamente, vicende fantastiche, fatti storici della lotta tra Modena e Bologna e avvenimenti di altre epoche (come la battaglia di Fossalta del 1249). La guerra per la secchia rapita si protrae a vicende alterne, fra battaglie, duelli, tregue e tornei, intercalati da episodi comici e burleschi, che hanno spesso come protagonista il conte di Culagna.
La bellezza del testo è da ricercarsi, tra le altre cose, proprio nella caratterizzazione di personaggi come il Conte. Nonostante Tassoni non approfondisca mai l’aspetto psicologico, soprattutto a causa dell’azione frenetica e costante che domina il testo, i personaggi restano comunque interessanti; soprattutto la figura del conte, che ben rispecchia il carattere polemico di Tassoni. L’autore infatti lo identifica con il conte Alessandro Brusantini; tra i due si era creata una lunga polemica letteraria e attraverso allusioni nemmeno troppo velate Tassoni fa trasparire il parallelismo, dipingendo il suo “avversario” come un “filosofo, poeta e bacchettone; / che fuor de’ perigli un Sacripante / ma ne’ perigli un pezzo di polmone/ Spesso ammazzato avea qualche gigante / e si scopriva poi ch’era un cappone / onde i fanciulli dietro di lontano / gli solean gridare – viva Martano!” (vv 97-100 lassa XII, canto III). Sacripante è un eroe dalla corporatura e dalla forza gigantesche ma Martano è il più vigliacco dei personaggi dell’Orlando Furioso.
Nel Conte di Culagna forse Tassoni volle dare una sorta di discendente a don Chisciotte, ma i due eroi non hanno nessuna parentela nonostante la vicinanza cronologica e l’inserimento in opere entrambe varie per stile e tono. L’eroe di Cervantes ha nobiltà d’animo ed è sorretto da una fede profonda, vagabonda per il mondo in cerca di un ideale; eroe a Lepanto sempre in lotta con l’avversa fortuna non si spoglia mai di una fiera dignità che lo rende nobile anche quando è coperto di stracci. Messo a dura prova dalle sofferenze, dopo aver visto svanire tutte le sue speranze e crollare le sue illusioni, rimane sereno, non impreca alla sorte; esce dalle bufere della vita con l’animo puro, e dal suo sorriso spunta un’ironia serena e malinconica che sa di bontà, di compassione e di perdono. Tassoni invece è uomo che nelle vesti di cortigiano e di ecclesiastico si lamenta sempre del suo stato ed è sempre inquieto. Don Chisciotte, ritto sul magro Ronzinante, attira la simpatia del lettore, è uomo di fede tutto immerso nel suo sogno contrastante con la realtà, è un allucinato ma è un eroe. Il Conte di Culagna invece è un personaggio che non ispira nessun affetto, e Tassoni quasi si compiace di tratteggiare un personaggio indegno di qualunque sentimento dolce.
Possiamo vedere questa caratterizzazione antimitica dell’ “eroe” della Secchia come il riflesso e l’eco dell’intero poema. Si prenda ad esempio la scena presente nel decimo libro, lasse 50-57) in cui la moglie del conte, resasi conto che il marito la voleva avvelenare per fuggire con Renoppia, scambia i piatti e sostituisce il veleno con del potentissimo lassativo. Il conte mangia con ingordigia e scende in piazza per non vedere la moglie morta e per vantarsi davanti a tutti di imprese inesistenti. Ad un certo punto, però, il lassativo fa effetto, e dai suoi calzoni esce “..un’improvvisa cacarola” che fa allontanare tutti a causa del suo “..tristo vapor”, persino gli speziali. L’unico che gli resta accanto è un confessore “ch’avea perduto il naso in un incendio” e dei suoi servi accorre soltanto una vecchia “con un zoccolo in piede e una scarpetta”.
Ancora un volta le aspettative del lettore vengono disattese e una situazione che si prospettava tragica (l’uxoricidio) o quanto meno cavalleresca (la fuga d’amore) precipita nel comico più triviale. La caratteristica che sembra definire sia il poema che l’atteggiamento dell’autore sembra essere proprio la sua sistematica imprevedibilità . Il critico Bàrberi Squarotti (Le strutture della Secchia Rapita, Studi Tassioniani, atti e memorie per il IV centenario della nascita di A. Tassoni, Modena, 1965) concentra l’attenzione sull’effetto di svuotamento dei materiali tradizionali operato dall’interno della tradizione attraverso il loro accostamento in un miscuglio spesso esilarante, comunque sempre nuovo e dissacrante. Ibid. : “La novità del Tassoni sta nel trattamento dei materiali, [... ] in quella mescolanza di stili [... ] di cui egli stesso si vanta: è la scoperta della relatività di tutti i linguaggi: eroico, comico, lirico, burlesco, dotto, cavalleresco, per una “congiunzione”che è la scoperta di un punto di vista diverso da quello assoluto che tutte quelle forme poetiche e quelle strutture avevano fino ad allora, preteso». Ovvero: ognuno è libero di trattare qualunque argomento nel modo che più ritiene opportuno, secondo l’estro del momento, ignorando il codice delle “convenienze”. Di fatto, l’oscillazione tra parodia del poema eroico, satira delle misere condizioni dell’Italia e invettiva personale nasce dalla necessità di toccare tutti i tasti, senza mai giustificare il cambiamento di argomento e di tono. È l’ultimo dei rovesciamenti del genere epico; la tensione epico eroica è sostituita dal distacco, dalla continua caduta, dalla risata che diventa il vero fine ultimo dell’opera.