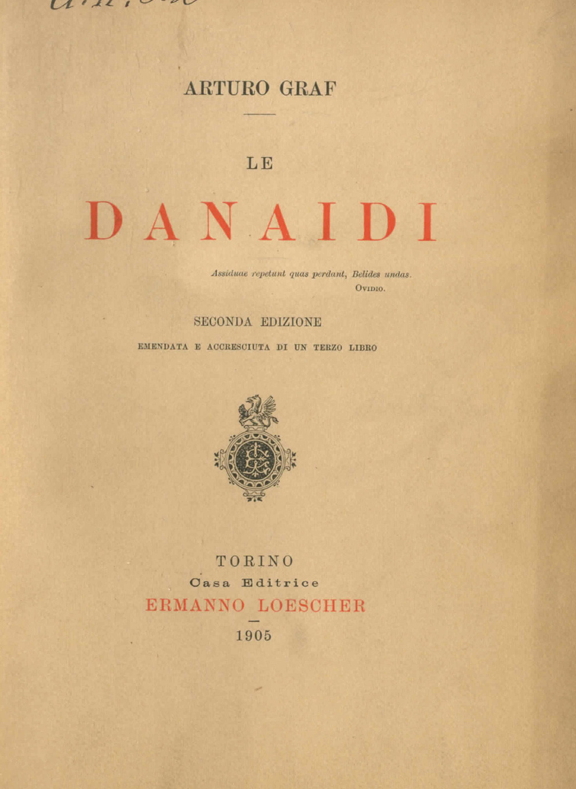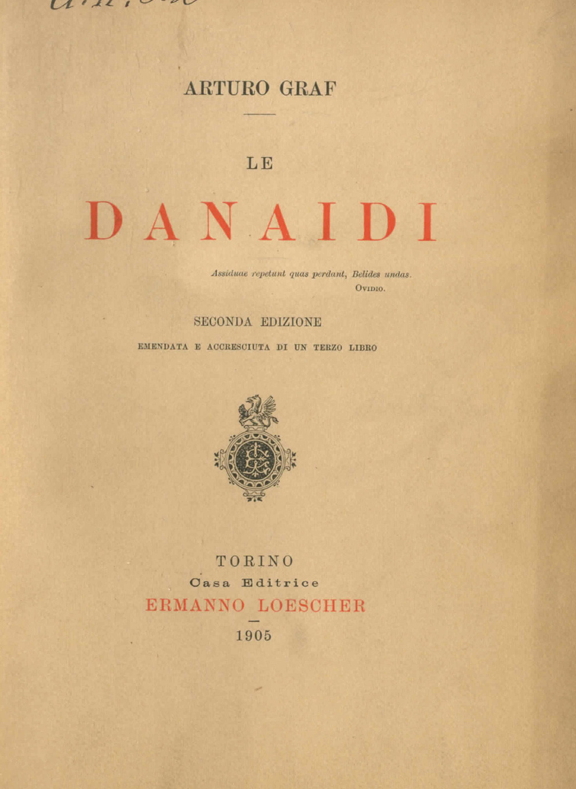Il 13 dicembre 1876 Arturo Graf, professore incaricato all’Università di Torino, lesse la sua prima prolusione al corso di Storia comparata delle letterature neolatine, insegnamento da poco istituito dal ministro Ruggero Bonghi.
Nell’Ateneo torinese si creò un clima di grande curiosità intorno al giovane professore dal cognome tedesco: il favore ottenuto da Graf superò ampiamente le aspettative e l’allievo Renier poté affermare che «parlò con lucidezza inarrivabile, con informazione sicura e precisa, con larghezza di vedute del metodo comparativo della storia letteraria».
Egli propose di applicare il criterio della comparazione anche alla «storia delle umane lettere», seguendo l’indirizzo proficuamente inaugurato dall’uso di quel metodo nella scienza del linguaggio: anche la fantasia, a suo giudizio, «ha le sue leggi, e la libertà umana è limitata anche nel dominio del capriccio. La […] menzogna della favola più stravagante è sempre condizionata assai da presso dalla verità della vita».
In ogni opera poetica, Graf rintraccia due matrici: una avventizia, fortuita, sarei per dir fenomenica, nella quale si rivela l’indole particolare, il particolare temperamento, la fisonomia propria di colui che l’ha prodotta; l’altra costante, necessaria, essenziale, in cui si riflette la coscienza e il costume del popolo in mezzo al quale l’opera fu prodotta, e in cui vive come si suol dire, lo spirito de’ tempi.
Tra le letterature dei diversi popoli si possono riscontrare notevoli affinità e si devono rintracciare «nel vario e nel mutevole il conforme e il costante»; i criteri e i procedimenti della storia delle lettere devono restare storici, ma ci si può servire del prezioso ausilio della psicologia, a suo giudizio allora finalmente degna del nome di scienza. Egli si rallegrava, inoltre, della nascita di una «estetica nuova», fondata «non sopra il gusto passeggiero di un tempo, ma sulle naturali qualità e proprietà delle cose» e utile, dunque, a intendere le forme d’arte «più prossime» come quelle più remote, sempre che gli studiosi si lascino guidare dalla «ragione» e diffidino dei facili indizi, attenendosi ai «fatti più stabiliti». Nel processo di «cognazione delle letterature», infatti, non si assiste mai ad una semplice imitazione, ma «le forme prese a prestito sono assoggettate a varii processi di elaborazione e di svolgimento, i quali possono a volte andar così oltre da mutar loro l’aspetto e da occultarne la origine».
Riguardo a quest’intervento, Ajello parla di «rivoluzione metodologica del gesto del comparare», operata da Graf proponendo di oggettivizzare il dato fenomenico, di precisare una prassi scientifica che porti allo studio dell’opera d’arte in relazione all’ambiente che la produce e a quello che la consuma; il giovane professore sistematizzando proprio una razionalizzazione, ancora di là da venire, dei meccanismi della «fantasia» portava mediante la comparazione, la psicologia proprio dentro l’estetica, e per questa via ancora e definitivamente la storia.
Rimasta vacante la cattedra di Letteratura italiana del Coppino, alla fine del 1876 ne fu affidato l’incarico allo stesso Graf, che inaugurò il corso, il 22 gennaio 1877, con una seconda prolusione, Dello spirito poetico de’ tempi nostri, in cui fece aperta professione d’italianità (e dopo la quale ottenne la cittadinanza italiana), nonostante fosse nato ad Atene e il padre fosse norimberghese: Partendo dal principio che il gusto poetico cambi naturaliter col mutare delle epoche storiche, Graf affermava essere inutile chiedersi se la poesia moderna sia superiore all’antica, avendo essa perso in «amplitudine» per guadagnare in «acuità». Egli sosteneva che la scienza e il realismo nuocciono alla poesia, che si nutre di mistero, oscurità e «dubbiezza», ed ha bisogno del mito; rispetto ai loro predecessori, i moderni, a suo giudizio, sono più concentrati su se stessi e sul proprio travaglio interiore, e la psicologia ha pervaso anche il romanzo e il dramma: al personaggio emblematico di Achille, tutto azione esteriore, si è sostituito quello di Amleto. Si prova «uggia della vita», nonostante l’incivilimento dei costumi e il progresso scientifico: la conoscenza del vero, anzi, ha condotto alla disillusione riguardo alla cruda e inesorabile necessità delle cose, cosicché «da questo contrasto del tendere a maggior libertà e del sentire più intera la schiavitù si genera negli animi nostri una vena inesauribile di amarezza. Ma una vena ancora di profonda e di sentita poesia». La percezione del dolore è entrata nel dominio della riflessione e ne ha acquisito la «tendenza all’infinito e al trascendente »: da ciò la moderna propensione all’intellettualismo in poesia.
Lo spirito poetico dei moderni è essenzialmente «subiettivo» e ciò spiegherebbe la prevalenza del genere lirico su quello epico: a giudizio di Graf, però, bisogna parlare di «mutazione» e non di «decadenza» del gusto. La tragedia, invece, la considera morta, essendosi perso il senso del tragico nell’esistenza. La forma poco curata, infine, lo stile «sciamannato dei giorni nostri» non sono solo frutto di negligenza, perché un «pensier tormentato ed instabile non può più trovar luogo negli incorniciati e scompartiti schemi del vecchio stile rettorico».
«La poesia non muore nel mondo […] – conclude Graf – muta forma, e tempra e carattere, ma non muore». Contemporanee a questa prolusione sono le tre lezioni accademiche apparse sulla «Rivista di filologia ed istruzione classica» nell’aprile 1877, per le quali Graf dichiarava di aver «lasciato allo scritto la forma libera e sciolta della esposizione orale».
Egli esordiva affermando che l’oggetto della storia letteraria è «la poesia in quanto espressione artistica del pensiero mediante la parola», e non le «forme sceverate dal loro contenuto». La letteratura scientifica, invece, appartiene alla storia generale della cultura, o a quella dello spirito umano, mentre la poesia didascalica rientra nella storia della letteratura solo se ha interesse estetico, poiché «la poesia non si propone e non si ha da proporre nessunissimo scopo»: la storia letteraria, dunque, si occupa dei grandi scrittori e dei minori che segnino momenti importanti nell’evoluzione del pensiero poetico. Riguardo ai metodi di studio, quello «biografico-cronologico», sebbene sia «il più disadatto», può aiutare a capire le reciproche influenze tra imitatori e scrittori originali; quello «estetico», più scientifico, rischia di spezzare l’unità poetica dello scrittore riconducendone le opere a generi diversi; quello «storico» finisce per non spiegare le «ragioni interiori »: perciò, «nello insegnamento si ha da usare di tutti e tre i metodi».
Graf ritiene che la letteratura a lui contemporanea abbia «pochissima intimità, e scarsissimo carattere nazionale» perché imita troppo tedeschi e inglesi, in poesia, e i francesi nel romanzo e nel dramma: del resto l’Italia si è dovuta adeguare troppo in fretta ai progressi filosofici e scientifici di altre nazioni. «L’indole non suole variare se non con estrema lentezza» – osserva – anche riguardo alla lingua, ma, al contrario di ciò che pensano i puristi «piagnoni», questi processi vanno assecondati e «il supremo legislator delle lingue ha da essere l’uso». L’esame delle origini delle letterature risulta di grande importanza, assieme a quello delle «derivazioni» da popolo a popolo: infatti, «l’imitazione servile dei capolavori torna sempre in grave danno della poesia, ma non così lo studio avveduto e giudizioso». In ogni caso, egli giudica più proficuo imitare i moderni rispetto agli antichi, perché ritiene che con essi abbiamo in comune almeno il pensiero. Tra i sussidi cui la storia letteraria può far ricorso, Graf ritiene importanti la paleografia (indispensabile allo storico della lingua), la bibliografia, la critica storica e filologica (soprattutto per le edizioni di testi), la critica estetica (da esercitare con cautela e moderazione) e la comparazione. Denuncia, invece, un abuso di «critica psicologica».
All’età di 28 anni, dunque, «cominciava il professorato: era finita la giovinezza » – annotava tristemente egli stesso. Eppure l’insegnamento fu per lui un’esperienza vissuta sempre con passione e partecipazione, ed egli considerò un’organica educazione dei suoi cittadini uno dei principali obiettivi che ogni stato dovesse prefiggersi. Tra le tante, una bella testimonianza sulle lezioni diede l’allievo Gallico; Renier ricorda che il maestro «componeva e riteneva nella memoria, non tenace per lungo tempo, ma impressionabile sì da conservargli alla lettera per tre o quattro giorni ciò che aveva pensato, pagine e pagine di prosa, lezioni intere». E Gallico racconta, infatti, che prima di cominciare ogni lezione Graf dava un’occhiata rapida ad un foglietto d’appunti che aveva in tasca, come promemoria, e poi iniziava a parlare: dunque, ci troveremmo di fronte a discorsi fatti a braccio, e successivamente scritti e pubblicati. Vittorio Cian ammonisce, però, a non pensare che quelle lezioni fossero frutto della più spontanea e felice improvvisazione, perché il maestro le meditava e preparava a lungo, e pare che anzi le stendesse sulla carta: la memoria agile e la sua innata arte oratoria da conferenziere provetto potevano trarre in inganno. In genere si rifaceva alla lezione precedente per istituire un legame col già detto, così come, alla fine dell’ora, «che non era l’ora “accademica” cara agli scansafatiche, […] raccoglieva le fila del suo discorso e preparava il campo alla lezione seguente, di cui enunciava il tema». Egli «costruiva abbattendo. Moveva spesso da qualche affermazione di critico insigne – molto spesso il De Sanctis – che sottoponeva a metodica, minuta, sottile analisi», ma mai con animosità o orgoglio: Cian ricorda, in particolare, una felice lezione sul Decameron, durante la quale il maestro discusse e confutò il noto giudizio desanctisiano secondo cui il capolavoro di Boccaccio sia da leggere come la negazione del Medioevo63. «Sentiva il bisogno di volgere l’idea da tutti i lati, […] o accostarla ad altre, istituendo impensati, originalissimi confronti». Non si appagava mai delle mete raggiunte, e dunque «scomponeva e ricomponeva per tentare sistemi che, subito dopo, intaccava fino a frantumarli». Aborriva dalle definizioni, e amava ripetere agli allievi: «Amoreggiate con le idee fin che vi piace; ma, quanto a sposarle, andate adagio». Egli derivò, forse, dal positivismo quell’esitazione nel giudicare e quello scetticismo riscontrabili negli innumerevoli interrogativi presenti nelle sue lezioni. Le prolusioni sono costellate di nomi, non esclusivamente di poeti o prosatori, e denotano una cultura di base onnivora, profondamente meditata e padroneggiata con grande sicurezza. Croce riconduceva ad una certa «ansietà» di carattere e, riguardo ai versi grafiani, parlò di un avvicinamento progressivo alla «poesia parenetica e parabolica», sulla quale gravava sempre una certa «prosaicità»: Graf attribuì tali giudizi negativi ad animosità personale, per l’aspra stroncatura che egli fece della crociana Leggenda di Niccolò Pesce, nel «Giornale storico della letteratura italiana» del 1885.
==>SEGUE