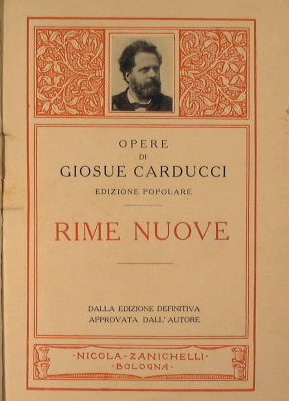Rime nuove
La raccolta Rime nuove, in nove libri, che raccoglie i componimenti scritti tra il 1861 e il 1887, testimonia una svolta, non cessa l'impegno civile, ma esso si spoglia dei panni satirici, ironici, di protesta che caratterizzavano Giambi ed epodi, e accanto a questo emerge una marcata vena elegiaca che percorre in lungo e in largo tutto il libro. Le radici di questo mutamento sono ravvisabili probabilmente, in un avvenimento biografico. Infatti nel 1871 conosceva e si innamorava dell'allora ventiseienne Carolina Cristofori. L'idillio amoroso durò un decennio, fino a quel fatidico 25 febbraio del 1881 quando la povera Lina moriva a soli trentasei anni, di tubercolosi. La musa lo ispirò e gli aprì il cuore e le sue poesie assunsero tonalità più soavi e delicate. Lo stimolo alla lettura di autori stranieri, che ella donna di grande cultura (conosceva infatti il francese, il tedesco e l'inglese) e sensibilità artistico-poetica gli infuse, contribuì a scuotere un po' di quell'accademismo libresco in cui era caduto e ad una modernizzazione della sua poesia. Si tratta in effetti di un opera multiforme non solo per le tematiche ma anche per i metri, anche se per un discepolo di Orazio questo poteva essere piuttosto normale. Il primo e l'ultimo libro contengono un componimento ciascuno, rispettivamente Alla Rima e Congedo. Nel primo si fa un po' la storia della rima con intento apologetico, intendendo rispondere all'articolo di Domenico Gnoli, uscito nel numero di dicembre del 1876 sulla "Nuova antologia", che la screditava. Essa si spinge tra moti dell'animo e "volgimenti di danza" tra "piè de' mietitori" e "virtù de' vincenti". Una rima epica quella delle Chansons des gestes si trasforma in poesia trovadorica e d'amore. Ed essa camaleonticamente muta, piegandosi alle lusinghe di Dante e trionfa pur combattuta e riverita tra i moderni. Nel Congedo il poeta traccia la sua figura e la sua arte partendo da ciò che egli non vuol essere, un poeta parassita e cortigiano, un perdigiorno sognatore romantico o un verseggiatore utilitaristico, e giungendo all'icona del poeta artiere tutto muscoli, che piega alle regola del metro e della rima anche i sentimenti più alti e che forgia con il battere e ribattere sull'incudine una poesia vigorosa e sana ma anche varia che canta, le glorie, le memorie, la libertà, la convivialità, la vittoria. L'ispirazione, il furor poetico che ha in se un qualcosa di misterioso e divino, viene lavorato a prezzo di grande fatica ma con la gioia di contemplare l'altezza del proprio genio. Il resto della raccolta vede prevalere, nel secondo libro, tematiche intimistiche e personali oltre all'elogio dei grandi spiriti dell'arte e dell'azione. Una dimensione metapoetica domina la prima parte del secondo libro ed egli vuole pagare il suo tributo poetico ai grandi maestri quali Omero, Virgilio, Dante, Ariosto. Ad Omero dedica tre sonetti, in cui c'è un'iniziale atmosfera cupa (I), infatti il monte degli dei, l'Olimpo, è divenuto un ossario greco-ottomano, lo Scamandro è stato empiamente deviato dal suo corso, ma se pur ci saranno nuove invasioni (II), si leva una certezza, la poesia di Omero attraverserà i secoli divenendo immortale come: "Ercole dalle pire d'Eta fumanti al seno d'Ebe". Ma lo iato tra "le grotte di Calipso bionda", Circe seduttrice, la splendida Nausicaa e il presente (III), egli lo preannuncia già in quei "giudici cumei" che allontanarono Omero, ma esplode nei versi finali con l'amara considerazione che (vv. 12-14):"E se tu ritornassi al nostro mondo, / Novo Glauco per te non troverei: / Niun ti darebbe un soldo, o vagabondo". Nel sonetto X, dedicato a Virgilio, la luna dal bianco chiarore che illumina il "rio", immagine sempre cara al "divin poeta", fa da preludio alla melodia dell'usignolo e al "viatore" che pensa a colei che amò, dimenticando il tempo passato e presente. La madre che piange il figlio perduto pur s'acquieta, volgendo gli occhi dalla tomba a quel mite chiarore del cielo mentre allietano gli animi i monti e il mare lontano e tra la fronde spira una fresca aura, il verso virgiliano, che invade, sì dolce e rasserenante, l'animo del poeta. L'ultimo verso è traduzione del v. 45 dell'ecloga V, delle Bucoliche di Virgilio. In Dante, rifiuta gli ideali religiosi e politici che lo guidarono nella composizione e celebra la sua poesia, come un "possesso per sempre", dal momento che resiste alla storia e agli ideali stessi. In Dietro un ritratto, il divin lombardo, Ariosto, dopo aver ultimato l'Orlando Furioso, rendendosi conto in che condizioni era il mondo, non volle ossequio di "prence" e di "volgo" o amore di "teologal donna", bensì di donna reale, Alessandra Benucci. Il dualismo vita-morte percorre poi, Funere mersit acerbo, in cui il Carducci affida il figlioletto Dante all'omonimo fratello che riposa accanto al padre, Michele, "[…] su la fiorita / Collina tòsca […]". Ma esso si perpetua anche nelle quartine anacreontiche di Pianto antico, ove il ricordo, la memoria, appare ammantata di primavera, di colore e calore in quanto si tratta di un passato vitale. Ma quell'albero inaridito, metafora del poeta scosso dal dolore e privo di speranze, è il primo passo verso la degradazione, lo scolorimento, la decomposizione esistenziale e il freddo delle morte, che connota invece il presente. La lirica si ispira come ricorda Manara Valgimigli, ai versi di un carme funebre per Bione, attribuito a Mosco, poeta bucolico alessandrino del II sec. a.C.. Il tema dell'amore per Lina, emerge in Panteismo in cui il poeta non svela mai a nessuno il nome della sua amata, ma è l'eco del suo animo a dichiararsi alla natura e tutt'intorno si alza un chiacchierio tra i vari elementi e esseri finché il "gran tutto" gli mormora: "Ella t'ama". Anche lui fosco poeta ha ceduto, quindi, ad Amore, ineluttabile. Ma i frangenti amorosi non furono sempre così sereni tant'è che in Anacreontica romantica, egli escogita di seppellire Amore, in modo da liberarsi di esso. Ma come un vampiro egli si sveglia nottetempo e opprime e vessa la mente del poeta con ricordi e immagini della donna amata. Allora solo un esorcismo fatto di disprezzo e vino può spezzare questo servitium amoris. Ed è proprio la fine di quest'amore a spingerlo in Tedio invernale, a domande esistenziali avvolte da una trasognata atmosfera mitologica da aurea aetas e così il mondo classico-epico è un trionfo di luce e purezza, di bellezza e amore, di virtù e gloria, mentre l'"ora" ha tutto il sapore di una caliginosa, nebbiosa, giornata invernale. Elemento fondamentale della musa carducciana è anche la componente paesaggistica. Traversando la Maremma toscana, si caratterizza per la fusione tra il rigoglio ambientale abilmente tratteggiato e la dimensione della memoria. In essa la natura natia, forgia il carattere sdegnoso e passionale del poeta ed è anche catartica, infatti quando si addensa un atro sconforto, basta uno sguardo all'orizzonte per rasserenarsi. Anche in Idillio maremmano protagonista è la natura, fiorente e piena di colori, in cui si muove la bionda Maria. Questa realtà povera ma sincera, alletta moltissimo il "grande artiere", che ben volentieri avrebbe preferito vivere qui e non essersi sfinito dietro al verso o ad indagare l'universo. L'immagine finale del novellare, accanto al focolare, di imprese nella caccia conferisce, se ce ne fosse bisogno, un colore ancor più paesano e diventa un'attività migliore e più soddisfacente del "suonare dietro ai vigliacchi d'Italia e Trisottini". Già a partire dal quarto libro egli prefigura con le tre Primavere elleniche, la stagione delle Odi barbare, come un ritorno alla "rosea serenità dei greci" che vuol essere una reazione contro il "brutto" della realtà. Nella Eolica, c'è una spinta, che convince il poeta e la donna, ad abbandonare i rovelli della vita civile e politica, le ristrettezze e le pene del vivere quotidiano, per giungere in un mondo sereno e incontaminato dove la bellezza e la giovinezza sono imperiture, è la Grecia mai vista, ma ricreata dalla fantasia del poeta. I due spiriti ormai fusi con la nuova realtà, fuggono e dimenticano "le occidue macchiate rive". Il poeta nella Dorica, invita Lina a seguirlo in un viaggio nell'"isola bella", la Sicilia, anche qui mai vista ma delineata attraverso i miti di Aci e Galatea. Qui egli non cercherà gli edifici eminenti dei tiranni dove risuonò il verso di Pindaro, ma le amene e selvose valli, dove sboccia l'idillio e nasce il canto di Teocrito. Si affollano intorno alla donna amata, numi omerici e ninfe che per liberarla della mestizia la accompagnano in luoghi inaccessibili e gli svelano segreti reconditi. Ma il poeta teme che gliela possano sottrarre e quindi dichiara che sarà lui a consolarla con la sua poesia che non ha nulla da invidiare a quella degli antichi. L'ultima, l'Alessandrina, poco ellenistica, dominata com'è dal senso della morte è ispirata da una visita cimiteriale si articola in visioni sepolcrali in cui risplende il binomio amore - morte. In una fredda giornata di maggio, piovosa e ventosa, la figura dell'amata risalta languida e rabbrividente e si muove verso l'eterna primavera dell'Eliso classico. La storia è trasformata in ballata, teatralizzata, come avviene per La leggenda di Teodorico. Nata da una contaminazione di due leggende "la germanica odinica l'italiana cattolica" e concepita dopo la visione ispiratrice delle formelle del duomo di San Zeno in Verona, si snoda, sul ritmo della ballata popolare, in una caccia fatale in cui l'empio predatore si trasforma in supplice e blasfema preda, lui che aveva ucciso papa Giovanni I, Boezio e Simmaco, e finisce precipitato da un "nero caval" nei crateri di Lipari. La visione finale con l'apparizione di Boezio non è di motivazione religiosa ma serve per sottolineare una volta ancora, la superiorità del mondo latino. Le vicende storiche e politiche dei comuni dei primi secoli del anno mille attrassero molto l'interesse di Carducci e la sua penna spesso tratteggia mirabili bozzetti anche se non di rado punteggiati di quel sogno e di quella immaginazione che già altrove abbiamo visto viva e operante, del resto si tratta pur sempre di poesia. Ne Il comune rustico, si assiste ad una ricostruzione fantastica della vita di un comune del mille. Dalla prima parte di impostazione paesaggistico-temporale, si passa poi alla presentazione di gesti e sentimenti semplici, quali le distribuzioni delle terre, la difesa, la paura delle donne. La polemica mette in evidenza come questa realtà semplice ma virtuosa e virile è scomparsa e si è dissolta in un mondo di corruzione quale quello attuale. Mentre in Faida di comune, si presenta una vicenda di un dissidio locale tra Pisa e Lucca sul possesso di alcuni paesi, che era nato susseguentemente ad un estremo tentativo di mediazione, fallito per l'arroganza dei legati lucchesi. Nonostante il colore locale, la vitalità di alcune scene come quelle dell'arruolamento dei pisani, la crudezza di altre come quella finale di Tigrin Sassetta che trafigge un prigioniero per due volte, si nota una certa mancanza di approfondimento storico e tutto si gioca su una alterigia, una iubris, piuttosto aneddotica, personificata da Bonturo Dati, punita dalla tisis pisana, di cui è emblema Banduccio di Buonconte. Il grottesco domina la pur storicissima figura dell'imperatore, in La ninnananna di Carlo V, delineandolo come ricettacolo di tutti i mali che quasi per una nemesi storica gli deriverebbero dalla sua triplice stirpe. Questo sembra un po' richiamare il motivo della triplice alleanza avversata dal Carducci, conclusa dall'Italia con Prussia e Austria nel 1882, in barba alle terre "irredente". Il settimo libro, costituito dai dodici sonetti del Ça ira, è teatro della vittoria dei repubblicani francesi (1972) contro le resistenze interne dei nobili e l'invasione degli eserciti austro - prussiani che volevano restaurare la monarchia. Duplice e quindi la linea di azione dei personaggi che si muovono in questa pagina poetica in onore della Rivoluzione. Quella dei Ça ira, è una storia liviana, che vive di grandi gesti estremi e teatrali, di figure che da sole offuscano la scena come Kleber "dagli arruffati cigli / leone ruggente" e Hoche "sublime", Beaurepaire che alla resa di Verdun risponde con la vita, per non cadere in mano nemica e i titanici Domouriez e Kellermann che sconfissero gli austro-prussiani a Valmy e risente delle opere di Michelet e Blanc. Le traduzioni dal francese, dallo spagnolo, dal portoghese e soprattutto dal tedesco (Heine, Goethe, Platen) caratterizzano l'ottavo libro. Con questa attività c'è una legittimazione del grande romanticismo europeo, quello prima maniera, che al nostro poeta piacque tanto. Ma il lavoro non si ridusse a pedisseque traduzioni, ma a vere e proprie contaminazioni e libere interpretazioni che fondevano il carducciano sentire con gli spunti europei. Ne La figlia del re degli elfi, ballata popolare danese, la figlia rappresenta la forza misteriosa e malvagia della natura, l'invidia e la perfidia tese ad ostacolare e a distruggere la felicità altrui. Fonde due romanze spagnole e una portoghese per creare Il passo di Roncisvalle. Il padre Carlo Magno, scopre che nelle schiere che hanno combattuto contro i Mori, manca Beltrano, suo figlio. Lui stesso va a cercarlo per valli, pianure, strade sterrate, foreste, di giorno e di notte e con il cuore in gola e gli occhi invasi dalle lacrime. Ormai persa ogni speranza di ritrovarlo, in lui l'animo altero prevale e lo porta a maledire tutto, finanche sua moglie che gli ha dato un solo figlio. Ma quando lo ritrova ormai morto, grazie ad una indicazione, l'ira si scioglie in commozione e rampogna il cavallo per non averlo portato in salvo e curiosamente il cavallo gli risponde. Da Platen trae Il pellegrino davanti a San Just, meta coventuale, ultima dimora di Carlo V, dove si rifugiò, stanco e sconsolato, scendendo dal soglio imperiale. La protesta è viva e si rinfocola in L'Imperatore della Cina (da Heine) in cui Carducci dipinge la figura del re di Prussia, Federico Guglielmo IV, che in preda ai fumi della "zozza" (bevanda alcoloolica), vede aprirsi davanti a se un panorama splendido. La realtà è ben diversa ed è eloquente che il Carducci prenda in prestito una realtà arretrata e chiusa in se stessa come quella della Cina per delineare la situazione prussiana nel suo ritorno ad un retrivo regime aristocratico-feudale. Sempre rileggendo Heine ne I tessitori riprende la voce dei lavoratori della Bassa Slesia che nel 1872 si erano ribellati e che maledicono l'alleanza della religione, del re, della patria. Il nostro poeta alla fine degli anni settanta inizia a inserirsi, a calarsi e irreggimentarsi in quella realtà da lui molto spesso combattuta. Dopo gli antagonismi giovanili e le imprecazioni contro la borghesia ora, visti gli esiti poco felici fino ad allora raggiunti vuole tendere ad un miglioramento dall'interno.
Pagina tratta da: giosuecarducci.iitalia.com/