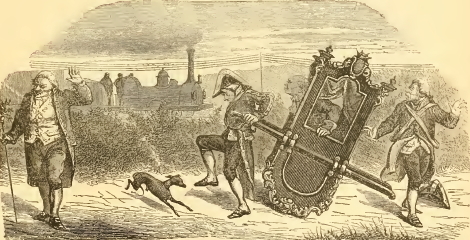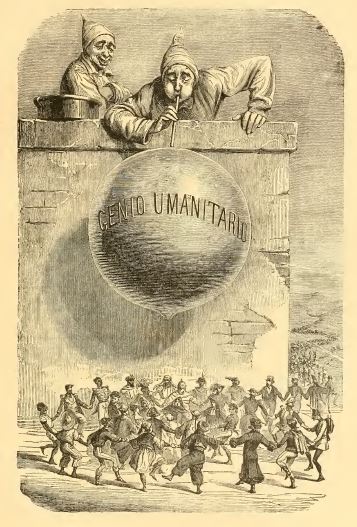La poesia di Giuseppe Giusti nasce, com’è noto, nel momento più difficile della politica italiana, quando le idee di unità, indipendenza e rinnovamento, alla base del Risorgimento, infiammavano gli animi spronando alla rivolta. Essa non trae origine da una delle solite forme impressionistiche che trovano le loro basi in un’idea frutto di sentimenti letterari, ma scaturisce da una reazione — alla sofferenza, al sopruso, al giogo straniero — che imprime nel cuore il desiderio di educare, formare e preparare il popolo al patriottismo. Ha uno straordinario ritmo agile e sincopato e, seppur costruita con grande attenzione e cura, sembra disinvolta e perfino ribelle alle regole. Con quell’arguzia e quell’impeto che gli sono abituali, Giusti produce versi fluidi e armoniosi che sanno “colpire il vizio” ed educare il lettore. Non mancano neppure le polemiche culturali e letterarie e nei suoi versi si ritrovano termini presi dal lessico quotidiano accostati a vocaboli dotti e raffinati, in latino e persino in francese, posti qua e là per rendere la provocazione ancor più violenta. Come in ogni buono scrittore di satira, ampio spazio è concesso alla rappresentazione ironica dei costumi del mondo italiano, colto negli aspetti più retrivi, ponendo alla berlina la politica reazionaria, il malgoverno e il malcostume; ma la sua satira mordace non raggiunge mai vette di estrema cattiveria, anzi si ripiega, talvolta, nella malinconia. Sulla fortuna letteraria di Giusti è stato scritto molto; esiste una bibliografia a dir poco sterminata. Eppure non è un poeta “canonizzato”, la sua causa di “beatificazione” è, infatti, tuttora aperta; lo si considera, piuttosto, un poeta complesso, il “contemporaneo” di tutte le varie epoche. E se rimane — agli occhi di qualche lettore poco attento — troppo paesano e prosaico, forse più uomo che poeta, con il suo acume intelligente ha saputo notare passioni, vizi, debolezze proprie di tutti i tempi e descrivere scene che, seppur pensate in Toscana, durante il regno di Leopoldo II, potrebbero gustarsi in qualsiasi parte d’Italia e in ogni tempo. Il più bel commento al Poeta è dato dai lettori, soprattutto quelli più anziani, che ricordano a memoria gran parte delle sue poesie. Quando il popolo umile, modesto, lavoratore, cita appassionatamente un verso, o parla di un poeta con entusiasmo, ciò significa che l’arte di quel poeta ha penetrato il suo animo facendogli vibrare le corde del cuore.
________________________
La vita di un Poeta
Giuseppe Giusti nacque a Monsummano Terme, nella casa dei nonni paterni, il 12 maggio 1809. Il padre, Domenico, era un proprietario terriero che tenne per molti anni l’amministrazione delle Terme di Montecatini; la madre, Ester, era figlia di un fiero repubblicano di Pescia, Celestino Chiti, che subì persecuzioni e carcere durante la reazione del 1799, dopo la discesa degli Austro-Russi nel nostro paese, e si fece ammirare poi per la generosità mostrata contro i suoi persecutori quando, tornato Napoleone in Italia, fu chiamato a ricoprire una carica molto importante nella sua provincia. Il Nostro nutrì sempre, fin da ragazzo, una grande ammirazione per il nonno materno, di cui nel 1837 scriverà la biografia; l’esempio di Celestino Chiti dovette influire notevolmente sulla sua formazione morale e più tardi sul suo orientamento politico, con grande disappunto del padre che sperava, anzi pretendeva, che il figlio prendesse a modello della propria vita l’avo paterno, quello di cui portava il nome e che aveva assicurato alla famiglia un notevole benessere e un elevato rango sociale. Amico e confidente del granduca Pietro Leopoldo, il vecchio Giusti era stato chiamato da questi alla presidenza del Buon Governo, una specie di direzione generale della polizia con attribuzioni molto ampie. Dopo la caduta dei Lorena ed il trionfo di Napoleone, seppe barcamenarsi così abilmente coi nuovi padroni che Maria Luisa, reggente del regno d’Etruria, lo nominò suo consigliere particolare e gli conferì un titolo nobiliare. Si capisce perciò che Domenico Giusti sognasse per quell’unico suo figlio maschio una carriera statale tanto brillante da rinverdire in famiglia le glorie paterne. Ma quel ragazzo, che pure mostrava un ingegno pronto e vivace, era destinato a dargli non poche delusioni: in primo luogo impiegando più anni
di quanti non ne fossero necessari ad ottenere una laurea in giurisprudenza e, in secondo luogo, mostrando ben presto una disposizione a mettere in burletta quelle istituzioni di cui avrebbe dovuto essere, nei sogni del padre, una solida colonna. Il cavalier Domenico, che a modo suo componeva versi ed aveva una gran passione per la musica e per la Divina Commedia, fu il primo maestro di quel figliolo ribelle ed inquieto, mentre la pratica religiosa fu affidata alla madre; «le prime cose che m’insegnò mio padre furono le note della musica e il canto del conte Ugolino», scriverà più tardi il Poeta in alcuni frammenti autobiografici:
Mio padre che avrebbe voluto fare di me un
Avvocato, un Vicario, un Auditore, insomma
un arnese simile, quando sapeva che io, invece
di stillarmi sul Codice, almanaccavo con
Dante, dopo aver brontolato un pezzo con me
e con gli altri finiva per dire: Già la colpa è
mia.
A sette anni, secondo l’uso delle famiglie agiate, fu affidato al precettore don Antonio Sacchi, guadagnando
parecchie nerbate una perfetta conoscenza
dell’ ortografia, nessuna ombra di latino, pochi
barlumi di storia […] e poi svogliatezza, stizza,
noia, persuasione interna di non esser buono a
nulla.
La modestia del primo precettore non impedì nell’allievo il formarsi precoce di un gusto letterario, orientato dai testi di scuola verso le biografie eroiche e gli episodi patetico- romanzeschi della presa di Gerusalemme. Nel 1821, all’età degli studi regolari, venne mandato a Firenze all’Istituto “Attilio Zuccagni”, dove ebbe per maestro Andrea Francioni, divenuto più tardi accademico della Crusca, il primo che gli metterà nel cuore «il bisogno e l’amore agli studi». La chiusura della scuola lo costrinse a lasciare Firenze per il liceo “Forteguerri” di Pistoia, dove si
fece notare più per la cattiva condotta che per il buon profitto. Nell’estate del ’23 passò al collegio “Carlo Lodovico” di Lucca e qui rimase due anni fino a quando fu espulso sempre per motivi disciplinari. A dodici anni iniziò a scrivere sonetti poi smarriti per incuria. Continuò a comporre anche una volta tornato a casa, a Montecatini, dove la famiglia si era trasferita dal 1815, e a Pisa, dove fu mandato per compiere gli studi universitari in giurisprudenza. Studente pigro e demotivato, dalla vocazione professionale insicura e ormai entrato in contrasto col padre, preferiva il Caffè dell’Ussero alle aule universitarie, mescolandosi ad allegre brigate, facendo conoscenze buone e cattive e collezionando debiti. La vita scapestrata e la «baraonda gioconda» che in Le memorie di Pisa si propongono come autentica lezione di conoscenza del mondo, culminano in un episodio di pubblica indisciplina: i tumulti studenteschi al Teatro dei Ravvivati, che gli fruttano una convocazione da parte dell’autorità di polizia. Il padre pretende che torni a casa, a Pescia, dove nel frattempo la famiglia si era trasferita. I tre anni seguenti sono i più tristi della sua vita: l’ambiente pesciatino ristretto e pettegolo lo priva di quelle soddisfazioni che Pisa gli aveva offerto; sola consolazione, sola àncora di salvezza, il continuo bisogno di scrivere versi: esercitazioni accademiche, sonetti amorosi, componimenti burleschi.
Così il tempo passa, ma intanto gli echi della rivoluzione parigina di luglio si propagano rapidamente in
Europa mentre, nel ducato di Modena, Ciro Menotti organizza quella temeraria insurrezione contro Francesco IV che gli sarebbe costata la vita. Giuseppe Giusti ne rimane colpito e commosso; le sue poesie di quel tempo, accese di un patriottismo generico ma sincero, restano a testimonianza della partecipazione spirituale ai nuovi ideali di libertà e d’indipendenza e segnano l’inizio di un impegno più serio nella sua attività di poeta. Questa improvvisa fiammata di sentimenti liberali rende ancor più difficili i rapporti col padre – conformista e devoto al Granduca – che, rassicurato dal fallimento dei moti romagnoli, lo rispedisce a Pisa per fargli riprendere gli studi. Nel giugno 1834, a venticinque anni, prende finalmente la laurea e si reca a Firenze per far pratica nello studio di Cesare Capoquadri, un principe del foro fiorentino; ma continua ad occuparsi di tutto fuorché di giurisprudenza. Tuttavia, dopo qualche tempo, per non rompere definitivamente col padre e per non dare un grosso dispiacere alla madre, ottiene l’abilitazione all’esercizio dell’avvocatura. Ma non volle mai esercitare la professione, anzi si arrabbiava se qualcuno lo chiamava avvocato. Intanto la sua fama di poeta era cresciuta, alcuni dei suoi vivaci scherzi satirici erano diventati popolarissimi, senza contare le liriche di stampo amoroso ispirate quasi tutte da Cecilia Burlini, maritata Piacentini, con la quale aveva stretto una relazione a Pescia nel 1829, relazione durata, tra alti e bassi, fino al 1836. La verità è che egli ebbe una sola grande passione: ‘la poesia’; per le donne della sua vita provò solo passioncelle e capricci nei quali avevano molta parte i sensi e poca il cuore. Si stabilì a Firenze. Intanto, però, la sua salute si stava aggravando e a nulla valsero i viaggi per ristabilirsi. Nel settembre del ’45 fu a Milano ospite di Alessandro Manzoni col quale aveva già intrecciato da tempo una relazione epistolare. L’affetto del grande “Sandro” e quello di Tommaso Grossi rappresentarono per lui la consacrazione letteraria, e gratificarono il bisogno di un apprezzamento anche umano della sua persona. Visitò Milano e i Laghi ma, soprattutto, discusse con Manzoni il fine della poesia ed accolse le critiche che questi muoveva sulla natura troppo personale della sua satira. Nell’inverno del 1845-46 si recò a Pisa a casa dell’amico Giovanni Frassi che avrebbe più tardi raccolto il suo epistolario e ne avrebbe scritto la biografia. Rientrato a Firenze, andò a stabilirsi nel palazzo dell’amico Gino Capponi, in via San Sebastiano – attuale via Gino Capponi –, dove rimase fino alla fine dei suoi giorni. Se le amicizie restano fedeli, tranne quelle oscurate in seguito da dissensi politici, i suoi amori si dispongono in un quadro più instabile e turbato. Al giovanile amore ideale per Isabella Fantoni, succede negli anni dell’università la tormentata relazione con Cecilia Piacentini. La bella signora pesciatina, madre del Giovannino destinatario di una lettera pedagogica, rappresenta un capitolo fondamentale della sua vita. La vicenda si conclude amaramente e con essa il Poeta congeda l’amica lontana e l’amore. Anche il legame con Isabella Rossi, poetessa e donna di fervidi interessi intellettuali, non lo rimuove dalla scelta di uno «scapolato» gaudente, appena incrinato da qualche rimpianto per la mancata vita familiare. Si susseguono poi alcune relazioni, per così dire, altolocate: quella con la marchesa Girolama U., nobildonna fiorentina, (a lei fu dedicato Il Sospiro dell’anima), e quella con Luisa d’Azeglio vedova di Enrico Blondel, fratello della prima moglie di Alessandro Manzoni. La “Marchesa” e il poeta si compresero e rimasero uniti da durevole affetto. Vedova e rimaritata, Luisa, nata Maumari, dovette essere consapevole della scelta fatta, per la quale ogni rapporto col marito, Massimo d’Azeglio, fu poi rotto per sempre. Ma, nonostante tutto, l’amore appartiene ormai per lui ad un universo di disvalori, e l’aridità interiore, rafforzatasi nella concentrazione sul proprio lavoro e sui propri mali fisici, autorizza il distacco e la freddezza. Nella quiete di palazzo Capponi continua il suo lavoro. La poesia, nel frattempo, accantona l’indagine sulla società e si lega alla cronaca politica, quasi a commento degli eventi che precedono il Quarantotto.
Il trionfo dell’ipotesi neoguelfa, dopo il Primato di Gioberti, modifica gli equilibri italiani ed incide sulla politica dei governanti. Le aperture di Leopoldo II, ottenute in seguito a vivaci sollecitazioni del partito moderato, creano un clima di attesa e di speranza che pare rispondere alle richieste mosse negli anni precedenti. Pur facendosi osservatore dei mutamenti positivi del momento, Giusti è in realtà spiazzato dagli avvenimenti. Assiste alle vicende rivoluzionarie della primavera del ’48 da palazzo Capponi e, solo
con l’ascesa al potere dei democratici, sposa la causa moderata. Nella primavera-estate del 1848 è occupato dall’organizzazione della Guardia Civica per la città di Pescia; eletto maggiore, al comando di un battaglione dimostra discrete capacità pratiche; partecipa alla prima e alla seconda legislatura concedendo il proprio appoggio ai governi moderati di Ridolfi e di Capponi e si attira, così, le ire della stampa di sinistra che lo accusa di tradimento. Nel 1849, però, non ha voti sufficienti per essere rieletto all’Assemblea Costituente creata dal governo democratico-rivoluzionario presieduto da Guerrazzi. La sfortunata campagna contro l’Austria conclusasi con l’armistizio di Salasco, il fallimento dell’ipotesi moderata, reso evidente dalla fuga di Leopoldo II e di Pio IX a Gaeta, il governo democratico a Firenze e la breve dittatura di Guerrazzi costituiscono eventi tragici per la sua lucidità mentale. Guerrazzi diventa il suo bersaglio e neppure la fine della dittatura e il ritorno del Granduca appoggiato dagli Austriaci lo distolgono dalla sua chiusura intellettuale. L’isolamento politico diventa anche solitudine morale e i dubbi sulla propria poesia si fanno così forti da costringerlo al silenzio. Alla satira sembra succedere il tentativo di un affresco collettivo.
Intanto, nell’aprile del 1848 viene eletto membro dell’Accademia della Crusca; tornato poi a Firenze all’inizio del 1850, dopo un inverno di malattia, muore in palazzo Capponi la mattina del 31 marzo, giorno di Pasqua, per soffocamento dovuto ad un improvviso flusso sanguigno. La sera del 1° Aprile il suo corpo viene portato nella chiesa di San Miniato al Monte, e lì seppellito. La vita e l’opera di Giuseppe Giusti furono segnate dalla concorrenza di due determinanti fondamentali: il conflitto nei rapporti col padre e il rifiuto del tipo di organizzazione e dei valori dominanti nella società italiana, e toscana in particolare, del suo tempo. Dal primo deriveranno quel rovello, quella insoddisfazione, quel senso di incompiutezza che caratterizzano la sua personalità e sono abbondantemente testimoniati sia dai versi che dalle prose (in specie quelle di tipo autobiografico o di confessione, assai frequenti nell’Epistolario). Esistono, nella sua struttura psichica, cariche atte a sviluppare tutta una serie di reazioni e difese, di spostamento e occultamento dell’ aggressività da una parte, di rassicurazione e riparazione dall’altra. Quelle della prima specie si identificano sostanzialmente col riso e con le sue forme giocose e satiriche, quelle della seconda comprendono l’apatia che è, a livello manifesto, disposizione a lasciarsi andare per sfuggire all’azione e ai contrasti e per sdrammatizzare le situazioni potenzialmente penose. All’angoscia della disgregazione e della morte si oppongono, quindi, tendenze costruttive, la tensione verso una comunione affettiva e sociale, assicurata da contrasti e dissonanze, che potremo chiamare il paesanismo-«chiocciolismo» giustiano:3 un massimo di chiusura ed esclusione del grande mondo che è poi solo una forma di rimpianto della condizione prenatale. Il condizionamento familiare va legato al contesto strutturale della società e del momento storico in cui il Poeta visse. Entro le coordinate storico-culturali proprie della Toscana, la sua posizione è tra le più singolari. Con chiara coscienza egli disdegnò di integrarsi nel sistema granducale della Restaurazione e, così, finì per essere un prototipo della figura moderna dell’intellettuale laureato disoccupato.
Di siffatta strozzatura storica, il nostro ebbe coscienza e cercò di definirla in una sua confessione:
Nella generale ipocondria che mette di mal’umore
i giovani del mio tempo, mi pare di ravvisare
un non so che di affettato e stucchevole.
[…] I desideri impronti, le speranze smoderate
ci avvezzano per tempo a stimarci degni di
ciò che è di meglio al mondo; d’altro canto,
una volontà fiacca in un corpiciattolo più fiacco
che mai c’inchiodano, per dir così, in una
poltrona di beata melensaggine ad aspettare
che la sorte ci dia l’imbeccata; intanto gli anni
passano, i sogni vanno in fumo e noi restiamo
lì grulli e scontenti, e buoni a nulla. […] Allora
versacci di rabbia intonacata di dolore, allora
romanzacci dove si calunnia Dio e l’umana
natura. Tempo fa la malinconia spingeva nei
monasteri o nei romitorii, oggi spinge a dar
fuori in istampa il disgusto di sé sotto colore di
romantiche ubbie.
La coscienza che avrà assai precisa della situazione del suo tempo fu condizionata a tutti i livelli dagli orientamenti della cultura dominante in Toscana. Un intellettuale come lui, specialmente negli anni giovanili, piuttosto che un ruolo di rappresentanza degli interessi di classe, sembra assumerne uno più mediato e universale. Negli anni pisani nutrì incomprensione per le posizioni più decise e radicali, specialmente se legate alle organizzazioni settarie, ma non fu esente da influenze democratico - repubblicane. La sua filosofia giudicativa fu il “buon senso”, saggezza pratica tratta dall’esperienza e dalla memoria paesana e campagnola (quella dei proverbi, di cui lui stesso fu sagace e convinto raccoglitore). Ma la “saggezza-buon senso” non gli consentiva di giungere all’analisi delle cause del problema toscano e italiano per cui la sua reazione rimase ad uno stadio emotivo e moralistico fatto di disagio e di ansia. Le sue idee, però, finirono con l’essere un adattamento alle posizioni della classe egemone, vale a dire di quel liberalismo moderato su cui modellò le proprie aspirazioni indipendentistiche e unitarie. E fu la poesia scherzoso-satirica il più efficace sfogo consentitogli; in questa, infatti, si confondono le due motivazioni della sua personalità: i dinamismi edipici – che lo portavano ad identificare il padre con gli oggetti del mondo socio-politico, emblemi di oppressione, inerzia e assenza di valori – ed il rifiuto della società della Restaurazione. Il suo mondo poetico è scomposto in “scene”, “scenette”, “farse”, “casetti”, la società appare come un confuso groviglio carnevalesco, gli uomini del suo tempo sembrano «burattini» o «pantomini», la sua stessa memoria, negli appunti presi, è fatta di «commedie vedute».5 Tale visione finirà con l’assumere un senso di espressione “corale”, è come se egli divenisse interprete degli oppressi e degli onesti in nome del buon senso. Affermazioni, queste, del tutto in linea con una poetica moderatamente romantica, di cui venne delineando i tratti per più di un decennio, dal ’35 in poi, ma senza un vero svolgimento. Fortemente influenzata dalle posizioni dell’“Antologia”, tale poetica è articolata sui principi dell’arte interprete dei bisogni del tempo, finalizzata al bene e all’utile, rappresentante del vero e destinata, almeno nelle intenzioni, al popolo. Il suo, però, è un romanticismo che si vuole collocare in una condizione di equidistanza dalle due scuole: libertà «dalle panie aristoteliche e dalle fuliggini sataniche» sul piano dei temi e dei motivi, per volontà di “paesanità”, e rifiuto dei suggerimenti stranieri in cui si paventa l’insidia di un asservimento anche intellettuale. Dunque egli non fu certo sprovvisto di una sua cultura
ma non fu neppure un gran lettore e non c’è ragione didubitare delle sue parole quando ad Atto Vannucci scrisse:
Ho avuto molta facilità di imparare, ho letto
pochi libri, ma credo d’averli letti bene assai;
del resto sono ignorantissimo di molte cose
essenziali, da far paura e pietà a me stesso.
Nella medesima lettera autobiografica accenna alla nascita e alla storia delle sue poesie:
Fino dal 1831, a forza di raspare senza guida e
senza concetto, m’era venuto fatto uno scherzo
sulle cose d’allora, e il favore degli amici, piuttosto
che il mio proprio giudizio, mi fece intendere
che poteva aprirmisi una via.
Subito dopo trascurò questa sorta di vocazione: si sentiva ignorante e aveva letto troppo poco. Poi riprese a comporre e
anno per anno ho seguitato, senza presunzione,
senza odio contro nessuno in particolare, e
senza tenere per moneta corrente tutto il bene
che me ne dicono e tutto il grido che me ne
promettono.
Così nascono gli Scherzi che si diffondono in copie manoscritte, per la Toscana prima e per l’Italia poi.
__________________________