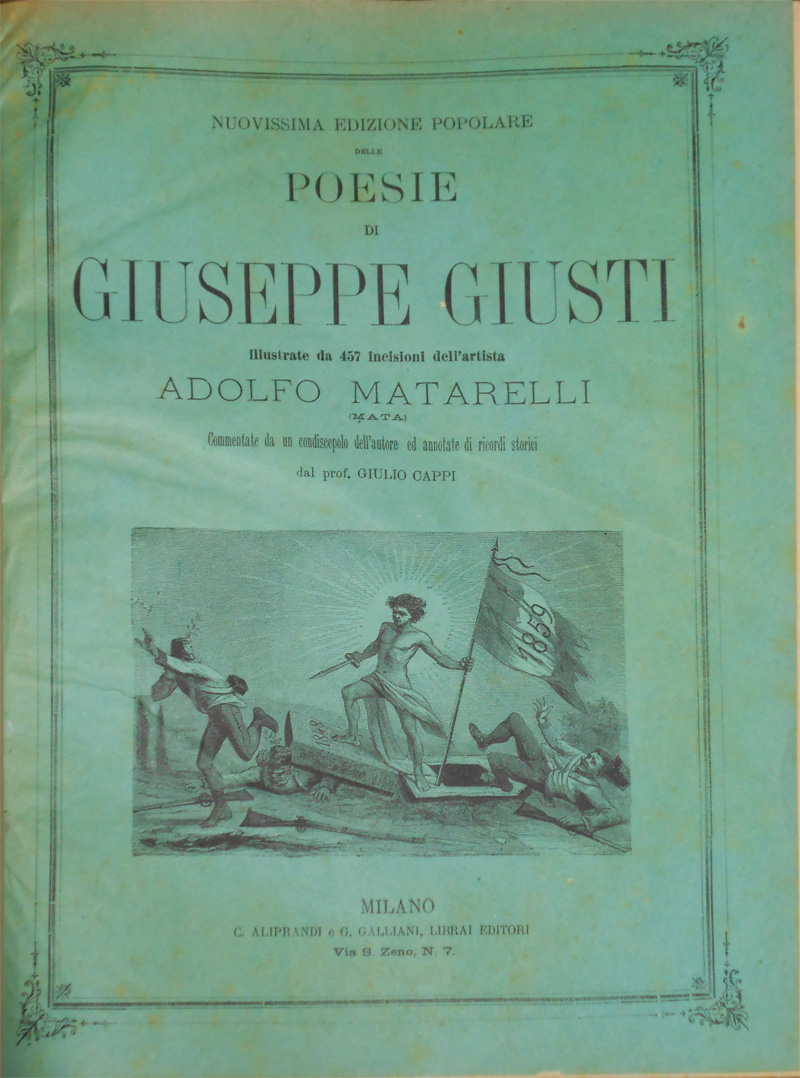La lirica prende spunto da un fatto realmente accaduto: mentre si trovava a Milano, ospite di Alessandro Manzoni, Giusti fece visita alla basilica di Sant’Ambrogio, al cui interno s’imbatté in un gruppo di soldati austriaci che a quei tempi occupavano il Lombardo-Veneto. Ad un primo sentimento di repulsione nei confronti dell’oppressore, si sostituisce una sorta di compartecipazione alla sorte di quei soldati che, lontani dalla patria, sono ridotti, forse loro malgrado, a strumento di sopraffazione. Il canto intonato da quei soldati suscita nel poeta una commozione inaspettata da cui scaturisce una riflessione profonda sulla sorte dei popoli che spesso sono soltanto delle marionette nelle mani di chi detiene il potere.
Giusti immagina di rivolgersi ad un alto funzionario della polizia o granducale (il poeta è pistoiese) o austriaca.
Fin dall’incipit si può osservare l’ironia con cui il poeta esprime la sensazione di essere guardato in cagnesco da quel funzionario che l’ha di certo etichettato come anti-tedesco perché nei suoi scherzucci si prende gioco dei birbanti (tiranni, traditori, finti liberali …). Dopo il preambolo, con quel O senta tutto toscano si appresta a raccontare al suo interlocutore ciò che gli era successo una mattina in occasione di una visita nella basilica di Sant’Ambrogio.
Il poeta si trova in compagnia del giovane figlio del Manzoni (forse Filippo), qui chiamato confidenzialmente Sandro e scherzosamente definito un di que’ capi un po’ pericolosi, riferendosi, senza mezzi termini, alla palese avversione che Manzoni nutriva nei confronti degli Austriaci e definendo il capolavoro del poeta lombardo romanzetto, prendendosi gioco anche di lui. L’intento di gabbare il funzionario si fa palese in quel Che fa il nesci (più o meno lo gnorri), salvo poi giungere alla conclusione che forse quel romanzo non l’ha letto perché il suo cervello ha tante altre faccende di cui occuparsi, prima fra tutte, è sottinteso, rendere infelici i poveri “oppressi”. Ecco che, proseguendo lo scherzo, arriva la sferzata per l’ignaro interlocutore: Dio lo riposi è un augurio che solitamente viene rivolto ai morti: il cervello del tale è, dunque, morto e sotterrato, constatazione che porta ironicamente l’attenzione del lettore sull’ignoranza e la pochezza di certi ufficiali.
Eccoci arrivati al racconto del fatto accaduto a Giusti in quel di Sant’Ambrogio. Nella basilica il poeta trova dei soldati, forse Boemi o Croati, popolazioni che allora facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico. Erano lì, come i pali che sorreggono le vigne, a controllare l’ordine, mandati dai funzionari austriaci (le vigne); l’ironia si coglie anche qui in quell’impalati che li descrive nell’atteggiamento servile di chi è sempre pronto ad obbedire. Anche i baffi che Giusti paragona alla stoppa (capecchio), riferendosi ai caratteristici “colori” di quei popoli, perlopiù biondi, costituiscono una nota ironica che si accompagna a quel dritti come fusi davanti a Dio, come se dovessero stare sull’attenti anche davanti al Creatore. Ecco che il ribrezzo, la repulsione prende il sopravvento: Giusti non ha voglia di mischiarsi a quella “marmaglia”, un ribrezzo che, ovviamente, il funzionario non può provare, visto che ci vive in mezzo abitualmente e che, proprio grazie a questo suo impiego che gli garantisce lo stipendio, riesce a sopportare. L’aria, poi, là dentro è decisamente viziata (e non può essere altrimenti visti gli “ospiti”), talmente pesante da far sprigionare persino dalle candele un odore non simile alla cera (che allora doveva essere di ottima qualità) quanto al sego con cui i soldati si ungevano i baffi. Insomma, sembra proprio che la sacralità del luogo risenta dell’influsso negativo di quei soldati puzzolenti.
Quel Ma nell’incipit della nuova ottava riporta l’attenzione sulla sacralità del luogo e ispira nel poeta una sincera commozione religiosa. Le note di un canto (nell’ottava seguente verrà specificato che si tratta del coro dell’opera verdiana I Lombardi alla prima crociata) rende l’atmosfera soave e nel contempo drammatica: si parla di un popolo che soffre fra gli stenti ricordando tutto il bene che ha perduto. Come non leggere tra le righe la sofferenza dei Lombardi, contemporanei di Manzoni e di Giusti, sottoposti all’ingiusta tirannia austriaca?
Il coro porta ad una specie di trasfigurazione del poeta che si sente parte di quella gente, di quel branco che prima aveva osservato da lontano e con disprezzo, come se non fosse più lui, rapito dalla musica e dal canto che lo inebria e lo porta ad essere solidale con chi forse non soffre meno di lui. E sì, ormai è totalmente rapito da quel pezzo nostro, perché legato al concetto di patria, perché appartiene alla nostra cultura, quella italiana, di cui nessuno straniero potrà mai privarci. Sull’onda emotiva di quella musica suonata con arte, ovvero “maestria”, passano in secondo piano anche l’ubbie, i pregiudizi. Ecco, quindi, che al cessar della musica, il poeta vorrebbe ritornare allo stato iniziale, a quella repulsione provata all’entrata in chiesa, ma involontariamente viene giocato da un nuovo tiro: dalle bocche che parean di ghiro (il riferimento ironico è ai baffi dei soldati, simili a quelli del piccolo mammifero) viene intonato un altro canto, questa volta tedesco, che s’innalza verso l’altare, una preghiera che è allo stesso tempo un lamento, un suono grave e solenne, ma contemporaneamente flebile, che gli rapisce per sempre l’anima. L’emozione è, quindi, temperata dall’ironia con cui dipinge gli austriaci: cotenne, in riferimento all’insensibilità come quella della pelle spessa dei maiali, e fantocci esotici di legno, espressione in cui l’aggettivo esotici rimanda a tutto ciò che è estraneo alla nostra cultura. L’empatia, attraverso la musica, si fa incredibilmente concreta.
Anche nel coro tedesco il poeta percepisce la rinascita di quel sentimento nostalgico di infanzia e di patria lontana. Il cuore custodisce e ripete nei momenti di dolore i canti imparati da fanciullo: gli affetti familiari, il desiderio di pace, la voglia e l’inclinazione ad amare in modo disinteressato, il dolore per la lontananza dalla patria sono sensazioni che il poeta non può fare a meno di condividere con quei soldati in un primo momento detestati. Anche il tono della poesia cambia e questa ottava costituisce l’apice del pathos.
Inizia qui la riflessione profonda di Giusti. A ben vedere questi soldati sono vittime anch’essi del potere: un imperatore timoroso dei moti insurrezionali, tanto in Italia quanto nei paesi slavi, strappa alle loro case (evidente qui la metonimia tetti) questi uomini che tengono schiavi noi pur essendo schiavi anch’essi. (evidente qui il chiasmo che rende ancor più drammatica la considerazione del poeta). Provengono dalla Croazia e dalla Boemia ma non sono poi molto diversi da quelle mandrie di buoi che i pastori toscani portano in Maremma a svernare.
L’ottava inizia con un’enumerazione per asindeto che rende particolarmente lento il ritmo dei primi versi. È come se il poeta volesse sottolineare il senso della desolazione che caratterizza la vita dei soldati, incolpevoli strumenti della rapacità consapevole (occhiuta rapina) del sovrano, senza goderne i frutti. La rapacità, poi, riporta allo stemma austriaco, l’aquila grifagna. Essi, sottoposti ad una dura disciplina e costretti ad una condizione di vita difficile, soffrono in silenzio e solitudine, subendo la derisione di chi li odia per quel che rappresentano. È un odio che divide (efficace, qui, la litote non avvicina) i due popoli, l’italiano e il tedesco, giovando a chi regna e può confidare nell’impossibilità di una loro complicità pericolosa. È il concetto del divide et impera.
Nei primi versi dell’ottava finale c’è ancora spazio per la commozione del poeta: la comprensione arriva alla pietà nei confronti di questa povera gente, lontana dalla patria e costretta a subire l’atteggiamento ostile del paese che l’ospita. Ma presto la pietà sfuma in umorismo e chiude ciclicamente la lirica: l’arguzia di Giusti arriva a definire principale l’imperatore che, forse, i soldati intimamente mandano a quel paese. Magari, è pronto a scommetterlo, non lo sopportano esattamente come gli Italiani.
Ma l’immedesimazione qui si ferma: per non correre il rischio di abbracciare uno di quei soldati, l’autore, ricordandosi del suo spirito patriota, deve fuggire. Il caporale rimane lì, con il suo bastone di nocciolo (era l’insegna dei caporali austriaci), impalato esattamente come l’abbiamo trovato all’inizio della poesia, insieme ai suoi compagni di sventura.
_____________________